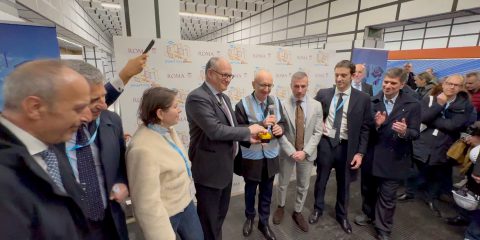Una volta c’erano le telecomunicazioni italiane: un fiore all’occhiello del Paese, con un’azienda, Telecom Italia (oggi TIM), che rappresentava un’eccellenza mondiale, con la politica che considerava la rete di tlc il cuore del sistema industriale nazionale e con gli ingegneri italiani di telecomunicazioni che erano tra i professionisti più ambiti a livello internazionale.
Negli ultimi venti anni tutto questo patrimonio è stato dilapidato. Oggi le telecomunicazioni italiane sono con il fiatone. Fanno fatica ad investire e ad innovare. Dulcis in fundo, l’intero settore non solo non è più amato dalla politica (che spesso si è fatta abbindolare nel corso degli anni dalle lobby dei giganti del web americani), ma è diventato addirittura del tutto marginale agli occhi degli stessi decisori politici.
Alle tlc italiane è di fatto mancato negli ultimi 18 anni un benché minimo straccio di politica industriale.
Nelle parentesi dei governi di centrodestra (2001-2006 e 2008-2011) a guida di Silvio Berlusconi il cuore batteva, ovviamente, solo per le TV.
La breve parentesi del governo di Romano Prodi (2006-2008), sempre sul punto di cadere per mancanza di numeri, partorì solo il piccolo bando di gara del WiMax.
Con il governo di Mario Monti (2011-2013), le Tlc non furono neanche considerate.
Il governo di Enrico Letta (2013-2014) può essere considerato, sulle tlc, come non pervenuto.
Infine solo con il governo di Matteo Renzi (2014-2017) scattò la grande operazione del Piano BUL, che prevedeva e prevede un programma nazionale di sviluppo della banda larga e ultralarga.
Il problema, dal momento del varo del Piano BUL a oggi, è che quella iniziativa fu congegnata come elemento di differenziazione e contrasto nei confronti delle strategie di Telecom Italia nel frattempo caduta nelle mani di un azionista come Vivendi: un investitore che non ha investito nell’azienda se non per aver acquistato le azioni, poco trasparente con il governo italiano (con cui non ha mai tessuto un dialogo e nessuno ha mai capito i reali obiettivi), motivato più dall’assalto al sistema televisivo di Mediaset che da uno sviluppo della rete, infine preoccupato di giustificare in chiave geopolitica l’intera iniziativa a propulsione francese (e quindi pan-mediterranea).
Ieri la svolta. Il ministro Luigi Di Maio ha annunciato che entro l’anno il governo intende dare definitivamente corpo alla nascita della società della rete, unendo gli asset di TIM a quelli di Open Fiber. L’occasione, inusuale, è stata la partecipazione a Non è l’Arena, la trasmissione di Massimo Giletti su La7. (Vai al video)
La domanda ovviamente sorge subito.
Sarà possibile fare in poche settimane ciò che non si è fatto in anni?
Di scorporo si parla, come è noto, dai tempi del Piano Rovati. La rete era considerata la “gallina dalle uova d’oro” (come la definì l’allora Sottosegretario alle Comunicazioni Antonio Catricalà). Eppure, nulla oltre le enunciazioni, che di volta involta hanno anche assunto connotazioni sempre più ideologiche.
Ma veniamo ai fatti.
Perché la rete deve essere unica?
L’operazione va fatta perché il mercato, secondo molti, non è in condizione di reggere due iniziative tra loro indipendenti. La verità è che le Tlc italiane sono in una condizione di stallo, che danneggia tutti e innanzitutto i due principali operatori: TIM e Open Fiber. Non vi è alcuna certezza e di fronte a questo, si sa, il mercato diventa nervoso.
TIM è in una fase di avvicendamenti continui di AD e compagine azionaria da almeno 3-4 anni. Con una situazione debitoria sempre più pesante e un flusso di cassa che anziché crescere si assottiglia continuamente. In sostanza, una condizione instabile che non fa comodo a nessuno e rischia di danneggiare tutti. La vera novità, è la prospettiva del Wholesale Only lanciata da Open Fiber, ovvero di un soggetto indipendente che vende fibra senza alcuna discriminazione a tutti gli operatori, i quali invece dovranno competere tra loro nei servizi sul mercato retail. Un modello originale e di tale dirompenza da aver convinto anche le istituzioni europee sulla possibile estendibilità della soluzione italiana a tutti i paesi dell’Unione Europea.
Quali ostacoli alla rete unica?
Qui ci sono diverse correnti di pensiero. Secondo alcuni, TIM dovrebbe mettere a fattor comune solo la fibra, secondo altri dovrebbe condividere tutti gli asset di rete: fibra, rame e accesso. Ma il problema, a ben vedere, non è questo.
La prima domanda a cui si fa fatica a rispondere è rilevante. Se la rete di TLC sarà gestita da una sola società, questa società nascerà da TIM che ingloba Open Fiber o da Open Fiber che ingloba TIM? Quest’ultima soluzione sembrerebbe la più ragionevole, visto che i vantaggi regolamentari sono possibili solo per un operatore Wholesale Only non controllato dall’incumbent.
L’altra domanda a cui invece sembra molto difficile rispondere è: che ne sarà del personale? Un problema sociale di non poco conto, che tra dipendenti e familiari coinvolge una massa critica non indifferente, anche a fini elettorali.
TIM ha oggi circa 50.000 dipendenti, di cui 20.000 circa sulla rete e il resto sui servizi. Quindi, c’è da immaginare che in caso di scorporo, questi addetti alla rete TIM dovranno passare in carico alla nuova società. Ma siamo sicuri che serviranno tante persone per gestire la rete? E degli altri dipendenti che si farà?
Ma non basta.
Se TIM dovesse scorporare la rete, rimarrebbero sui servizi poco meno di 30.000 persone. Ora, qual è l’operatore che per gestire i soli servizi deve ricorrere a un esercito così cospicuo di dipendenti?
In Italia gli altri operatori (alcuni dei quali hanno in carico anche pezzi importanti di rete) gestiscono i servizi con poche migliaia (non decine di migliaia) di dipendenti. Insomma nessuna soluzione sembra rispondere alla domanda chiave: che ne sarà di tutti questi dipendenti di TIM (30.000 dei quali sono già oggi in “solidarietà” sindacale)?
Quale futuro per la governance di TIM?
Il nodo centrale è quello rappresentato dall’attuale amministratore delegato Amos Genish, voluto da Vivendi, poi avvicinatosi al Fondo Elliott, oggi apparentemente distante da tutti, ma con in predicato un bonus fin troppo impegnativo per un’azienda che versa in difficoltà. Genish è al centro del campo e guardando lui si può capire forse dove andrà il pallone. Sta spesso all’estero, vive a Londra, guarda al Brasile, si destreggia da una parte all’altra nelle relazioni tra i principali azionisti. Infine tutti si chiedono quanto resterà e la maggior parte degli organi di stampa ha già detto che difficilmente supererà la boa di fine anno. Si fanno già i nomi di possibili successori, tutti debitamente interni al Cda, ma si evita di fare l’unico vero nome papabile, per il quale quelli che contano stanno lavorando.
E allora che succederà?
Difficile dirlo. L’esito della partita in corso non si deciderà solo sulla base delle volontà che il governo avrà di completare una storia senza fine che i precedenti governi non hanno voluto o potuto chiudere.
Il nodo da sciogliere è come sistemare decine e decine di migliaia di dipendenti che potrebbero far affogare qualunque architettura societaria, anche la più sofisticata, di fronte ad una “carenza” di sostenibilità.
I mercati non capirebbero e qualsivoglia soluzione darebbe luogo ad una soluzione insostenibile, se prima non si decidono proprio questi due nodi cruciali: la formula di merger tra i due soggetti (TIM e Open Fiber) e il destino di alcune decine di migliaia di dipendenti.