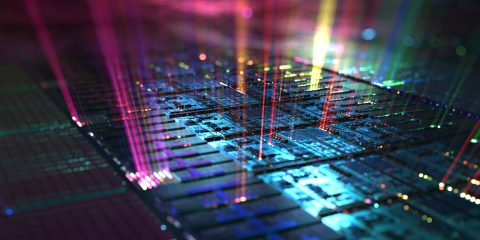Italia

#PAdigitale è una rubrica settimanale a cura di Paolo Colli Franzone promossa da Key4biz e NetSquare – Osservatorio Netics. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui.
Mentre ancora non è chiaro il futuro della governance dell’Agenda Digitale (la telenovela dell’AGID e del suo statuto, l’ormai imminente uscita di Francesco Caio dalla struttura di missione al netto da eventuali sorprese), il mercato IT specializzato in forniture alla pubblica amministrazione e alla sanità continua a manifestare sofferenze.
Il combinato disposto tra mancanza di risorse finanziarie e incertezza in assenza di indirizzi, la domanda non compra e l’offerta non vende. Peraltro, in quei rari casi in cui qualcuno vende qualcosa molto spesso si finisce travolti dal ciclone dei ricorsi (che rallentano – mediamente – di un anno i tempi di fornitura) e quasi sempre ci si schianta con tempi di pagamento in qualche modo ridotti rispetto agli anni scorsi ma ancora del tutto inaccettabili.
La situazione è talmente critica che da almeno un anno cominciano a essere in difficoltà anche non poche (per non dire tutte) società ICT “in house”, quelle possedute da Regioni e/o enti locali e presenti in praticamente tutto il Paese (13 Regioni su 21).
Questa situazione di difficoltà fa riemergere il discorso complessivo sul senso dell’esistenza di società pubbliche che di mestiere scrivono software e/o gestiscono data center. Un discorso iniziato qualche anno fa in seguito all’emanazione della “Legge Bersani” e poi in qualche modo dimenticato.
Stiamo parlando di un insieme di società e consorzi che fatturano all’incirca 750 milioni di Euro su un mercato complessivo (PA locale e Sanità) non superiore ai 3 miliardi, dando lavoro a poco più di 5.000 persone alle dirette dipendenze e ad un indotto stimabile intorno alle 1.500 unità (perlopiù consulenti “di fascia bassa”, analisti e sviluppatori pagati al massimo ribasso e con tempi a volte molto vicini al biblico).
Faccio subito una premessa: non mi iscrivo al partito di coloro i quali vorrebbero far sparire del tutto (chiudendole o privatizzandole), queste società. Già in passato Netics (società che ho fondato e che dirigo) ha prodotto documenti di analisi del fenomeno evidenziando come continui ad essere necessaria la presenza di strutture “leggere” destinate a esercitare funzioni di “Agenzia per l’Innovazione”: la governance strategica, la regia complessiva, gli acquisti di tecnologie e soluzioni applicative.
Ciò che deve essere eliminato (mettendolo sul mercato) è quello strato di attività – numericamente considerevole – che va dallo sviluppo di software applicativo alla conduzione di infrastrutture IT e al “fleet management”. Attività che nessuna società “in-house” può assicurare a prezzi paragonabili col mercato, anche in considerazione delle limitazioni geografiche (giustamente) imposte dalla Legge Bersani e alla conseguente impossibilità di arrivare a economie di scala.
Il problema è evidente e si sta trasformando in “problema serio” da quando non poche Regioni hanno dovuto ridurre sensibilmente i loro budget destinati all’ICT.
In Piemonte, ad esempio, la più grande organizzazione in-house italiana in termini di forza lavoro impiegata e seconda per volume di ricavi, ha dovuto ricorrere alla cassa integrazione guadagni per alcune centinaia di dipendenti e sta pagando i suoi fornitori con quattordici mesi di ritardo.
Netics ha analizzato tutti i bilanci depositati delle ICT in-house (esercizio 2012): il quadro complessivo è desolante. Ricavi in caduta libera, salvo pochissime eccezioni; uno stock di indebitamento rilevante a fronte di crediti altrettanto importanti (gli enti che tardano a pagare anche i loro debiti verso strutture “captive”).
Il problema vero è che nessuna di queste in-house è in grado di decidere da sola un budget ricavi: tutte dipendono dai loro pochi (in qualche caso, unico) clienti e dai tagli più o meno imposti da situazioni contingenti. Nessuna possibilità di integrare questi ricavi con attività extraterritoriali, se non pochi spiccioli provenienti da attività su mercati esteri (attività consentita dalla “Bersani”).
Un piccolo “gruppetto” di in-house ha avviato un percorso virtuoso di collaborazione coi privati: dalla esternalizzazione di asset (il datacenter di Lombardia Informatica) alla creazione di “cluster” insieme ai fornitori (CSI Piemonte e – in misura minore – Informatica Trentina).
Ma i problemi continuano a persistere, e non pochi presidenti di regione o assessori competenti – nel più rigoroso anonimato – dichiarano la loro intenzione di giungere a una soluzione “definitiva”.
Soluzione che parte da un “dimagrimento” (separazione delle attività di “Agenzia” da quelle di “Fabbrica”, incentivazione di piccoli spin-off, esternalizzazione dei data center e delle attività di assistenza e fleet management) e che arriva alla vendita tout-court.
Quella della privatizzazione delle ICT in-house è un’ipotesi affascinante, che però già una volta si è schiantata contro una realtà non così troppo ricettiva (la tentata vendita di Insiel, trasformatasi poi in una vendita parziale di un singolo ramo d’azienda) in presenza di un contesto complicato: strutture “pesanti” (alcune in-house hanno staff perlomeno sovrabbondanti), resistenze di parte della politica e del sindacato, impossibilità delle amministrazioni cedenti a garantire ricavi per un numero di anni sufficiente a “far quadrare i conti”.
Ma le società ICT in-house possiedono (praticamente tutte) asset interessantissimi: parecchie centinaia di persone in possesso di una perfetta competenza di dominio (i “business” specifici delle amministrazioni loro clienti) e (in molti casi) infrastrutture tecnologiche di ottimo livello.
“Merce preziosa” per potenziali acquirenti.
Si tratta, quindi, di capire come fare a rendere “sexy” le in-house, rendendole attrattive nei confronti di potenziali acquirenti.
L’unica strada percorribile “in concreto” (aldilà delle fantasie e dei proclami) è quella di avviare un percorso in due tappe: si parte da un radicale ripensamento dei rapporti tra la in-house e l’ecosistema dei suoi fornitori, eliminando del tutto gli acquisti di “giornate uomo” a favore di programmi condivisi su singoli task (i sistemi amministrativo-contabili, la sanità, l’agricoltura, ecc.) avviati in modalità di partenariato.
Sulla falsariga di quanto fatto tra il 2010 e il 2011 in CSI Piemonte e in Lombardia Informatica, migliorando ulteriormente il modello eliminando l’aleatorietà dei “contratti quadro” e generando cluster virtuosi altamente specializzati, la cui componente privata sarà in grado di portare a valore gli asset a livello nazionale e internazionale, non avendo i limiti imposti dalla “Bersani”.
La seconda tappa è la naturale conseguenza della prima: la cessione (onerosa) a privati dei singoli cluster avviati, comprese le risorse umane ad essi afferenti. Nel frattempo, si inizia a far cassa (e a “dimagrire”) vendendo i data center a soggetti ai quali verrà garantito un contratto pluriennale (non meno di 7 anni) relativo all’utilizzo di quei data center da parte delle amministrazioni cedenti.
Il modello è “win win“: le amministrazioni risolvono un problema, i partner privati portano a casa un business capace di generare altro business, i dipendenti delle in-house vengono progressivamente spostati sulle componenti private dei clusters. I privati coinvolti nei clusters conferiranno competenze e asset tecnologici capaci di “rinfrescare” sensibilmente soluzioni applicative che in molti casi oggi sono ai confini dell’obsolescenza.
Rimangono in capo alle amministrazioni delle strutture “snelle e smart” di Agenzia: poche decine di dipendenti, l’esercizio della governance e il coordinamento strategico dei sistemi informativi regionali (sanità compresa).
E’ uno scenario percorribile, o è fantascienza?
Ai politici l’ardua sentenza. Consapevoli che qualsiasi altro percorso, basato sulla speranza che arrivi un “cavaliere bianco” pieno di soldi e di incoscienza, appartiene al mondo delle favole.