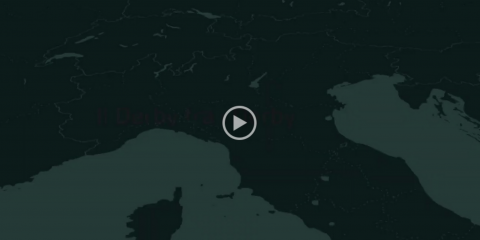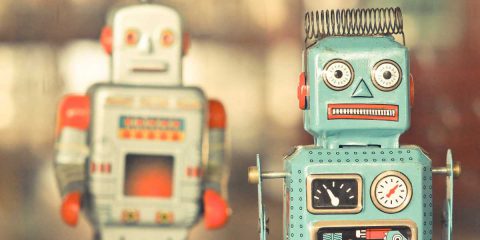Questo intervento è tratto dal libro appena pubblicato “Investimenti, innovazione e nuove strategie di impresa. Quale ruolo per la nuova politica industriale regionale?”, a cura di R. Cappellin, M. Baravelli, M. Bellandi, R. Camagni, S. Capasso, E. Ciciotti, E. Marelli, Edizioni EGEA, 2017.
L’economia italiana è, come è noto, in una condizione di stallo. Il Paese non cresce da anni, la struttura produttiva è a rischio di deindustrializzazione, la disoccupazione giovanile è cresciuta con modalità inarrestabili e molto più vistose rispetto a quelle di qualsiasi altro Paese europeo, si è allargata la forbice delle disparità del nord del Paese con il Mezzogiorno, il mondo della produzione è sempre più distante da quello dell’università e quest’ultima, pur potendo rappresentare un punto di riferimento di conoscenza, non può contare su un sistema-Paese capace di valorizzare appieno le sue competenze a beneficio del mondo della produzione.
Tra le principali cause dello stallo dell’economia vi è la totale assenza di una politica industriale. Nel corso degli anni è stata negata l’idea stessa di politica industriale e il suo tema è stato cancellato dal dibattito politico. Il risultato è che l’assenza di una regia, prerogativa principe della politica, ha fatto danni e condanna l’economia nazionale a restare nella crisi, se non interverranno elementi di inversione di tendenza.
Sono passati nove anni dall’inizio della disastrosa crisi finanziaria del 2008 che ha coinvolto il mondo intero, ma nel frattempo molti Paesi (in specie in Europa) hanno trovato, pur tra le inevitabili difficoltà e con soluzioni e strumenti differenti, la propria strada per affrontare il cambiamento necessario, per assicurare il cambio di passo senza il quale non si possono affrontare avversità non previste, di portata globale e tali da imporre un nuovo modo di guardare alla crescita economica da tutti auspicata.
In Italia ciò non è avvenuto e in questi nove anni abbiamo anche avuto, rispetto agli altri Paesi, una esasperata frammentazione della continuità politica necessaria alla realizzazione di percorsi di lunga durata. I problemi vanno affrontati dai governi e i governi devono poter durare a lungo, non solo per decidere, ma anche perché quelle decisioni hanno bisogno dell’esercizio di responsabilità di chi le ha assunte.
In tutti questi anni gli investimenti, sia quelli di provenienza pubblica sia quelli privati, sono crollati. L’innovazione di prodotti e di processi nell’industria manifatturiera, abbandonata all’inventiva e alla capacità di resistenza di questo o quell’imprenditore, si è dissolta. Le infrastrutture digitali, che i più citano con riferimento ai servizi digitali (rinnovando fino allo stordimento la querelle dell’uovo e della gallina), ci vedono agli ultimi posti della scala europea. Alla crisi del rapporto tra politica e mondo sindacale si è affiancato un indebolimento sostanziale del ruolo negoziale delle stesse rappresentanze imprenditoriali, infine il sistema decisionale degli enti territoriali è stato posto in una condizione di isolamento a favore delle decisioni del governo centrale, escludendo ogni confronto, mediazione e negoziazione realizzativa con gli enti di territorio: un approccio dirigistico, verrebbe da aggiungere, difficile da digerire nell’Italia dei Comuni e dei 100 campanili.
Infine, un ulteriore impoverimento del quadro italiano è stato segnato dal ricorso del tutto contingente e strumentale a bonus e sostegno alla domanda, che ha determinato una polverizzazione di interventi esasperata e l’implicito rafforzamento di un equivoco di fondo ovvero che la rimonta economica fosse solo nelle mani del consumatore e non vi fosse invece l’esigenza più ampia di una nuova visione di sviluppo e di crescita, con una nuova dinamica tra le forze di mercato.
Gli effetti della crisi del 2008 vanno tuttavia considerati a livello globale, non solo in relazione alle scelte nefaste della finanza di rapina che li ha determinati, ma anche nel più ampio cambiamento economico e tecnologico indotto dallo sviluppo della rete, dalla illimitata disponibilità di informazioni e dal modo in cui esse vengono usate come una risorsa di inestimabile valore (Big Data), da una riformulazione delle specializzazioni produttive e geografiche che hanno caratterizzato la manifattura mondiale sino a due decenni fa, da un generale riposizionamento nel ranking delle economie mondiali.
Per effetto di tale straordinario cambiamento il mondo non sarà più come prima.
Rispetto ad altri Paesi che hanno e stanno affrontando la trasformazione in atto con un approccio evolutivo, l’Italia ha bisogno di vere e proprie discontinuità per fronteggiare gli svantaggi competitivi determinati dalle mancate o errate scelte degli anni passati da parte dei governi e delle classi dirigenti del nostro Paese: una direzione di marcia sbagliata che ha creato condizioni del tutto inidonee rispetto alle sfide del presente e del futuro.
Ciò che più pesa sull’Italia è la mancanza di una politica industriale all’altezza delle difficoltà registrate e dei cambiamenti annunciati dalla trasformazione globale degli ultimi anni, una politica industriale capace di trovare soluzioni per fronteggiare ataviche difficoltà (come quelle del rilancio del Mezzogiorno o il dramma della disoccupazione giovanile), e fare le scelte necessarie per sollecitare e accompagnare una nuova ondata di crescita economica, allineata appunto allo sviluppo della tecnologia e alla globalizzazione dei mercati.
L’Italia ha sostanzialmente mancato quella fase di riallineamento al nuovo ordine che ha invece caratterizzato le decisioni politiche ed economiche della maggior parte dei Paesi avanzati ed è stata vittima di una “vacanza decisionale” delle proprie classi dirigenti che ha marchiato il tessuto produttivo e che ha accentuato quel progressivo impoverimento del Paese che è sotto gli occhi di tutti.
Abbiamo così subito la pressione proveniente dai paesi emergenti (spesso avvantaggiati, come nel caso dei cinesi, da politiche di dumping) che hanno danneggiato numerosi prodotti tipici del Made in Italy. Parallelamente, abbiamo patito il rapporto comparativo con i diretti competitor europei, che hanno invece potuto contare su sistemi-Paese orientati da precise politiche industriali e pertanto capaci di coniugare al meglio policy, investimenti, innovazione.
Un elemento di novità tra le acque ferme dell’economia italiana potrebbe esser dato dal Piano Impresa 4.0, annunciato dal governo nel dicembre 2016 in occasione dell’approvazione della legge di Bilancio 2017.
Si tratta di un Piano importante, anche se forse un po’ troppo ideologizzato nelle modalità di presentazione, perché indicato come panacea di ogni male dell’industria italiana.
In effetti, il Piano ha vistosi punti di debolezza e la sua realizzazione sembra aver bisogno di significativi correttivi. Si tratta di correttivi di sistema più che operativi, relativi all’impianto concettuale del Piano piuttosto che alle modalità realizzative. Viene difficile immaginare la realizzazione di un piano triennale così impegnativo, per gli effetti a cascata che potrebbe generare per gli anni a seguire, in assenza di una di politica industriale del governo e con un’accentuazione delle preesistenti lacerazioni tra centro e periferia che hanno accompagnato molte delle scelte dirigistiche degli ultimi anni. Quanto più le scelte sono impegnative, tanto più necessitano di partecipazione e consenso. Senza il soddisfacimento di questi aspetti fondamentali sarà difficile che il Piano possa rispondere positivamente alle attese in esso riposte.
Industria 4.0 prevede un intervento di 13 miliardi di risorse pubbliche, per attivare investimenti innovativi con incentivi fiscali.
Un’ulteriore dote da 10 miliardi circa viene indicata nel Piano per le cosiddette “direttrici di accompagnamento”, una tecnica usata da tutti i governi per mettere nel calderone misure decise precedentemente e scaturite da altri contesti decisionali. Si va dalla diffusione della banda ultra-larga per le imprese (6,7 miliardi già stanziati) al rifinanziamento del Fondo di Garanzia PMI (900 milioni), dalla detassazione del salario di produttività (1,3 miliardi tra il 2017 e il 2012) alle catene digitali e all’internazionalizzazione del Made in Italy (100 milioni), dai contratti di sviluppo con focus su Industria 4.0 (1 miliardo già stanziato) ai capitoli a sé che riguardano scuola, università e centri di ricerca. Tra le priorità dichiarate figurano, in aggiunta allo sviluppo della banda ultra-larga, l’efficienza energetica, la crescita dell’occupazione e il sostegno alle imprese innovative.
Ma se prendiamo la prima delle priorità indicate, la banda ultra-larga, ci si rende conto di come il Piano soffra di incoerenze e disarmonie, contando su prerequisiti non ancora disponibili e la cui realizzazione potrebbe svolgersi secondo tempi asincronici rispetto al calendario realizzativo di Industria 4.0.
Un elemento esplicativo a tale riguardo è quello rappresentato dall’esigenza di avere una rete infrastrutturale per la trasmissione dati moderna e veloce. L’obiettivo fissato dal governo – tutte le imprese servite da rete a 30 MBit/s entro il 2020 e il 50% da almeno 100 MBit/s – pur non particolarmente ambizioso, se confrontato con le medie di molti Paesi europei, appare come una sfida titanica, se si considerano con i dati relativi alla attuale disponibilità di banda.
Confartigianato ha ricostruito, elaborando i dati Istat, un quadro impietoso dell’Italia della rete. Il nostro livello di copertura e di sviluppo di reti fisse di nuova generazione è tra i più bassi d’Europa. E siamo al penultimo posto per le condizioni di velocità della rete. Appena il 12,5% delle nostre imprese ha potuto utilizzare nell’ultimo anno connessioni di banda ultra-larga veloce. Nell’Unione europea, invece, la media d’imprenditori che sfruttano banda ultra-larga sfiora il 27%. Rispetto ad altri Paesi come la Danimarca, non c’è confronto possibile, se si pensa che la metà delle aziende utilizza da anni connessioni veloci. Ma ci superano abbondantemente anche nostri diretti competitor come Germania, Francia e Spagna.
In sostanza l’esistenza di un’infrastruttura di rete a banda ultra-larga, che dovrebbe rappresentare un prerequisito, uno strumento abilitatore del Piano, è indicata essa stessa come un obiettivo da raggiungere all’interno del Piano medesimo (e come tale è sottoposto a tutte le incertezze del caso) e rischia di condizionare con l’eventuale sua mancata o parziale realizzazione, anche altri obiettivi e servizi del Piano medesimo.
Per realizzare il Piano Industria 4.0 è stata istituita anche una “cabina di regia” che si è insediata immediatamente e di cui fanno parte Governo e parti sociali (in particolare Governo, ministeri, imprese, sindacati, CDP, università e centri di ricerca), ma che, ancora una volta, non considera per nulla gli enti locali ovvero le cosiddette rappresentanze di territorio (Comuni, Regioni, aree metropolitane, comunità montane), cui non è riconosciuto alcun ruolo. Si tratta di una manchevolezza di non poco conto, se si considera il radicamento sociale e logistico delle imprese che s’innervano naturalmente nei territori sui quali insistono.
Secondo le buone intenzioni del governo, sono tre i principali processi che guideranno il Piano Industria 4.0.
Il primo è quello di una completa digitalizzazione di tutte le operazioni delle aziende. Tali processi di digitalizzazione si espanderanno sia verticalmente (attraverso una diversa gestione dell’intera gerarchia e delle relazioni funzionali tra i vari apparati interni alla struttura organizzativa aziendale) sia orizzontalmente quindi l’intera filiera (collegando fornitori, partner, distributori che trasmettono e condividono dati tra di loro senza frizioni o blocchi).
Il secondo è quello della ridefinizione di prodotti e servizi, che saranno integrati con software e hardware capaci di tracciare l’experience del cliente (dall’Internet of Things alle soluzioni blockchain non solo nel settore Fintech, ma anche in tutte le operazioni di verifica e certificazione delle identità digitali).
Il terzo è quello delle interazioni avanzate e profonde con il cliente. Sviluppando nuovi processi, prodotti e servizi viene a crearsi un’intera catena del valore altamente reattiva proattiva che permette un rapporto quasi simbiotico di scambio dati tra il consumatore e il produttore. In pratica il cliente (in ambito B2B) o il consumatore (nella catena consumer) esprimendo opinioni, giudizi e in generale attraverso la sua presenza in rete (autorizzando gli strumenti di tracciamento capaci di generare procedure di Analytics ovvero capaci di generare reportistica automatica) sarà generatore di enormi quantità di dati (Big Data) che saranno molto utili per affinare le azioni di marketing delle aziende, definendo meglio i prodotti e offrendo servizi e prodotti del tutto personalizzati e in linea con le esigenze del cliente-consumatore.
Il quadro sin qui tracciato tende a modificare il modo in cui le cose sono state sino a oggi realizzate. L’essenza, in generale, dell’industria 4.0 è la connessione tra macchine, tra macchine e prodotti, tra persone e prodotti, infine tra persone. Il che vuol dire che non solo faremo prodotti e servizi nuovi (e faremo in modo nuovo quelli preesistenti), ma ci saranno nuove relazioni con il consumo e nelle modalità di incontro tra domanda e offerta.
In questo senso, ciò che appare più rilevante sono le logiche economiche sottostanti ai guadagni di produttività che derivano in generale dalla digitalizzazione delle attività industriali e di servizi.
Vi è innanzitutto un inevitabile aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse, grazie a decisioni migliori, perché basate su informazioni più ricche e disponibili in tempo reale. L’utilizzo di sistemi di analisi automatica dei dati (data analytics) e il ricorso all’intelligenza artificiale consentono l’assunzione di decisioni in modalità automatiche e decentrate.
Secondariamente, l’efficienza nell’uso delle risorse valorizza i processi produttivi assegnando e riconoscendo una più elevata produttività del lavoro e del capitale.
Infine, efficienza nella gestione e valorizzazione di lavoro e capitale, interagendo con le straordinarie opportunità della rete, scatena una corsa disruptive verso nuovi modelli di business e relazioni contrattuali del tutto diverse rispetto al passato.
In questo contesto, tutti i settori sono collegati e sono parte integrante di un unico gigantesco sistema. Ed è un mondo nuovo di organizzazione del mercato e della società di cui si fa fatica a percepire effettivamente la portata.
Ma torniamo alla proposta del Governo.
Il Piano Industria 4.0 punta sulla carta a radicali cambiamenti nella struttura produttiva del Paese. Viene tuttavia difficile immaginare come sia possibile dar seguito a un tale sviluppo tecnologico nelle modalità produttive, decisionali e di relazione tra prodotti e consumatori auspicate, se non si metterà mano, appunto, a sostanziali correttivi.
A fronte degli obiettivi dichiarati, che sono d’indiscussa rilevanza, il Piano sconterà inevitabilmente i limiti del proprio disegno progettuale che circoscrive le misure previste entro un perimetro fin troppo ristretto di acquisizioni strumentali di tecnologie, un approccio che non deve sorprendere.
L’Italia è indietro, si sente spesso dire, perché non è stata al passo con le tecnologie. Si tratta di un motivo ricorrente in ampi settori dell’opinione pubblica italiana, secondo il quale il ritardo italiano è essenzialmente di natura tecnologica, dovuto in sostanza ad un deficit di cultura della modernità tecnologica. Spinto all’eccesso l’assunto porta a una risposta inevitabile: dotiamoci di tecnologie e potremo superare il gap rilanciando la crescita. Ma non è così. Non si può assegnare un tale potere taumaturgico alle tecnologie senza considerare i processi, le procedure, le semplificazioni di funzionamento dell’intero sistema produttivo e dell’ecosistema sociale nel quale il mondo della produzione opera.