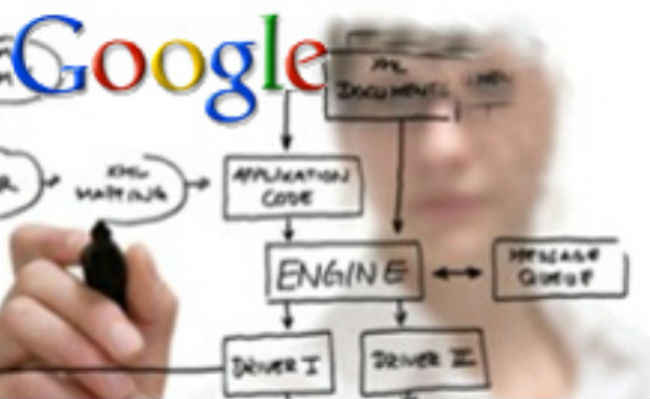Si apre formalmente la guerra dell’algoritmo.
Con il fondo pubblicato oggi, venerdì 28 novembre sul Corriere della Sera, a firma del vice direttore Daniele Manca, dall’esplicito titolo “Noi nudi davanti a Google”, diventa così senso comune anche in Italia il tema della dittatura dell’algoritmo.
Per la prima volta l’emergenza di un nuovo potere digitale che incrina e crea squilibrio nel sistema delle relazioni sociali ed istituzionali sopravanza la solita predicazione sui diritti negati alla rete.
Il voto del Parlamento europeo sul potere dominante che il gruppo di Mountain View ha ormai accumulato in Europa, con la conseguente necessità di separare l’attività del motore di ricerca dall’offerta dei servizi accessori, tipica norma antitrust che il liberalismo americano ha insegnato al mondo, rende più concreta e visibile il nuovo conflitto.
Persino una vestale del libero mercato anglo americano, come il magazine Economist rileva il problema, mettendo il copertina il logo di Google con la domanda: Should Govermment break up digital monopolies?
Al momento, almeno in Italia, a guidare la critica a Google rimane la fragile tematica della privacy. Ossia di un sistema di diritti, tutti interni alla sfera del potere dell’individuo, assolutamente e liberamente negoziabili, in cambio di servizi e commodities. Cosa che Google sa benissimo e pratica su scala planetaria. Tu mi concedi le informazioni sul tuo profilo, io ti faccio fare bella figura nel lavoro e nelle tue relazioni supportando il tuo sapere e la tua potenza di calcolo.
E’ questo uno scambio che noi stessi pratichiamo da tempo, quando usiamo una carta di credito o un telepass.
Diverso diventa invece il tema che affiora dal voto del Parlamento europeo e dalla copertina dell’Economist.
Quanto può essere tollerata l’efficienza e la potenza tecnologica di un unico gruppo quando questo gruppo insidia l’autonomia e la sovranità di stati, comunità, e individui, nell’organizzare i propri saperi e trasmettere le proprie culture ai successori?
In realtà è questo il vero tema. Siamo, niente più e niente meno, che a quel 24 gennaio del 1984, quando Apple trasmise nel corso della finale del Super Bowl americano a San Francisco lo shoccante spot televisivo di Ridley Scott sul nuovo personal computer di Steve Jobs. Lo spot faceva il verso al libro di George Orwell “1984”, e ammiccava allo scontro con un grande fratello tecnologico e culturale che si identificava con l’allora gigante IBM, e terminava con l’esortazione: “Affinché il 1984 non sia un 1984”.
Il tema si ripropone: la rete per non essere un grande fratello deve emancipare la conflittualità dei saperi o omologare in virtù di un gigantismo tecnologico? E l’accresciuto protagonismo del software nella nostra vita quotidiana può permetterci di delegare, come quotidianamente facciamo oggi, ogni nostro pensiero alla sintesi digitale che Google ci ammannisce con i suoi servizi?
La prospettiva di aprire la scuola elementare al pensiero computazionale, come si chiede a gran voce, può essere occasione di una ennesima delega a Google, che produce i principali tool tecnologici per la formazione di base?
E ancora, l’imminente riorganizzazione del sistema editoriale e giornalistico, insieme a quello televisivo, può essere condotta semplicemente importando algoritmi di Google, come sta avvenendo?
Allarma che perfino una comunità di esperti e intellettuali critici, come quella raccolta dalla Commissione sui diritti della rete, insediata dalla presidenza della Camera e guidata da Stefano Rodotà, continui, all’alba del 2014, a porre il tema di promuovere l’accesso alla rete, purchessia, piuttosto che rendere evidente che oggi, come spiega Bauman, il vero digital devide non riguarda l’uso di questo o quel congegno digitale quanto l’impossibilità di concorrere alla creazione di senso comune.
E l’algoritmo è oggi linguaggio e strumento per organizzare pensieri e parole del senso comune. Più ancora di quanto cinema e letteratura potessero fare negli anni precedenti.
E se su questi due settori prima gli Usa, e poi la stessa Europa, hanno introdotto palesi eccezioni al liberalismo economico, codificando la necessità di proteggere i propri pensieri e le proprie opere, con leggi che supportavano l’eccezione culturale, non si vede perché su una materia mille volte più pervasiva e minacciosa dobbiamo preoccuparci solo di come Google venda i nostri dati a produttori di biscotti.