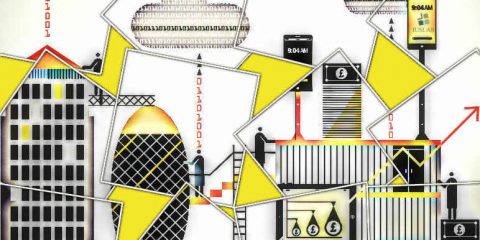La teoria dell’Innovazione Dirompente o Disruptive Innovation non è una tra le tante brillanti idee controverse e suggestive in circolazione. Anzi, è sempre più agevole vederla in azione e facilmente si notano novità inattese di mercato raggiungere clienti e praticare al pubblico prezzi più bassi grazie all’effetto tipico della c.d. disruption.
La rubrica Fintech, in collaborazione con l’Avv. Giulia Aranguena di ADLP Studio Legale e la redazione del blog Iuslab, approfondisce i temi dell’innovazione tecnologica in ambito bancario e finanziario e le nuove tendenze di mercato in questo settore. Per consultare gli articoli precedenti clicca qui.Clayton Christensen, che ha lanciato la teoria nel 1997 nell’opera “Il dilemma dell’innovatore”, sostiene che l’alterazione del mercato prodotta dalle innovazioni dirompenti di solito è fatale per le aziende old school e gli incumbent già insediati nel mercato, che si trovano difronte soltanto l’alternativa di restringersi su business model sostenibili anche nei nuovi scenari oppure soccombere.
Se è vero, questa è una cattiva notizia per le banche e da più parti si sollevano moniti che invitano a prendere atto, velocemente, di come l’Information Technology stia incanalando in modelli economici alternativi il dissapore e la disaffezione createsi nei loro confronti a partire dalla crisi iniziata nel 2008.
Forme di consumo collaborativo stanno prendendo sempre più piede e il modo in cui siamo abituati a vivere, lavorare, commerciare e pagare si sta trasformando rapidamente sotto i nostri occhi.
Così come l’affacciarsi delle c.d. cripto currencies ha ulteriormente confermato, il consumo collaborativo nel settore del banking, soddisfa quattro bisogni chiave ed è sempre più attrattivo per questo. Infatti, esso dimostra:
(1) che ci sono costi “sovrabbondanti” che possono essere tagliati a beneficio dei consumatori;
(2) che il modello gestionale della c.d. banca universale,[1] nato nel XIX secolo, è inutilmente complesso, obsoleto ed inidoneo ad essere trasposto efficacemente in una dimensione 2.0;[2]
(3) che il principio cardine della “fiducia” nei middle man tradizionali è andato in panne;
(4) che le persone escluse dal vecchio sistema finanziario tradizionale possono trovare nuovo accesso ed “inclusione” bancaria.
Secondo Rachel Botsman, autrice di “What’s Mine Is Yours: Collaborative Consumption Is Changing The Way We Live”, l’attività bancaria si trova ora nello stesso punto in cui si trovava l’industria dei media cinque anni fa, o dove era l’industria musicale quando fu colpita da Napster; mentre tutto sommato il banking, secondo alcuni fanatici della disruption, non sembra essere cambiato molto dai tempi in cui le persone portavano il bestiame al mercato ed ottenevano un pezzo di carta in cambio.
E’ vero, il 2014 è stato un anno di innovazione dirompente e si è delineato il nuovo settore fintech. Si sono affacciate banche online, come la tedesca Fidor ad esempio. E’ venuto fuori il c.d. robo-advisor, il servizio di investimento offerto da piattaforme online, che, grazie ad algoritmi di risk management e asset allocation, riescono – in pochi minuti ed ad una frazione del costo di un professionista – a costituire portafogli personalizzati proponendo soluzioni acquistabili direttamente su Internet (i.e. Wealthfront, Motif Investing, Betterment). E si è registrata la consacrazione definitiva del crowdfunding nell’arena del capitale di rischio.
In breve, una nuova generazione di aziende di tecnologia finanziaria ha cominciato a sfruttare Internet, tecnologie mobili e sociali, cloud computing e Big Data per costruire e portare al mercato soluzioni innovative, cambiando il modo in cui i servizi finanziari sono accessibili, consegnati e sperimentati dai consumatori.
Tutto questo, se da un lato dimostra che i quattro benefici della riduzione dei costi, della rottura della complessità del banking tradizionale, del superamento del sistema basato sulla fiducia e dell’inclusione finanziaria sono vincenti su tutta la linea, dall’altro potrebbe far pensare ad esiti davvero funesti per le banche; soprattutto per quelle europee che, per effetto degli accordi di Basilea, risultano plasmate sul modello di banca universale e sulla medesima struttura gestionale pesantissima che avevano prima della crisi finanziaria del 2008.
Quindi, sembrerebbe proprio che ci siano tutte le condizioni per tirare in ballo la teoria convenzionale e dominante dell’innovazione dirompente, secondo la quale gli operatori storici del mercato lottano contro l’agilità dei nuovi entranti con lo stesso stile di goffi mammut destinati a morire in una pioggia di piccole frecce.
Ma alcune evidenze suggeriscono, invece, che ciò non è necessariamente quello che accadrà nella finanza, visto che le banche, da sempre molto impegnate con la tecnologia, hanno cominciato a reagire in vari modi dando ben più di un segno di vitalità e rinnovamento.
Alcune startup, ad esempio, sono state lanciate appositamente per aiutare gli incumbent bancari ad adattarsi, come la londinese PayLiquid che ha costruito la soluzione per vendite cloud-based che consente il funzionamento del POS mobile Barclaycard Anywhere per accettare pagamenti con carta sul proprio smartphone.
Inoltre, c’è BBVA, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, la banca basca che ha investito in Coinbase un exchange per valute digitali e che attraverso Open Talent fornisce un programma di accelerazione di impresa con sede a Barcellona. E ci sono molti altri esempi, come la nostra UniCredit che ha creato lo Start Lab a Milano con uno spazio di co-working e supporto per startup specializzate in fintech, o HSBC che ha, invece, istituito un fondo dedicato di 200 milioni di dollari finalizzato ad investimenti diretti con l’obiettivo di migliorare i propri sistemi tecnologici.
La strategia preferita per la maggior parte delle banche sembra essere quella di creare programmi di avvio per incubare aziende fintech (come dimostrato dall’esempio di BBVA e di altre banche); ma non disdegnano, in alternativa, di collaborare con aziende fintech, né di acquistarle direttamente lanciando proprie filiali, né, soprattutto, di impegnarsi nel settore attraverso canali alternativi, dando supporto ad iniziative fintech attraverso enti e associazioni (come il caso di Innotribe, lanciato con il supporto del circuito Swift, per esempio).
E’ abbastanza per soddisfare la teoria della Disruptive Innovation e sfiancare l’agilità del nuovi entranti?
Probabilmente non importa dare una risposta all’interrogativo, e non solo perché la teoria dell’innovazione dirompente è stata seriamente messa in discussione negli Stati Uniti dalle aspre critiche (assai motivate) della professoressa di storia americana di Harvard, Jill Lepore, che l’ha letteralmente smontata dalle colonne di un editoriale del New Yorker di qualche mese fa.
Ma soprattutto perché, al di là delle teorie e delle parole, almeno oltre oceano le banche, come riportato da American Banker, hanno cominciato a reagire apertamente al peso della iper-regolamentazione che le rallenta rispetto ai nuovi entranti, intraprendendo precise azioni di pressione volte all’ottenimento di una regulatory relief che consenta loro di misurarsi competitivamente in un settore “in which an upstart refuses to play by the established rules of engagement, and blows things up” (Jill Lepore, The Disruption Machine).
Note:
[1] Il modello di banca universale (simile al vecchio sistema di “banca mista”), per effetto delle direttive comunitarie, è consacrato nel nostro sistema nazionale dall’art. 10 del TUB che stabilisce che le banche possono svolgere, oltre alle attività tipiche di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, anche ogni altra attività finanziaria nonché attività connesse e strumentali (fatte salve le riserve di legge).
[2] Cfr: articolo sul Sole 24ore, a firma del Prof. Donato Masciandaro, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-11-01/il-modello-sbagliato-banca-universale-20-081140.shtml?uuid=ABRKpF9B