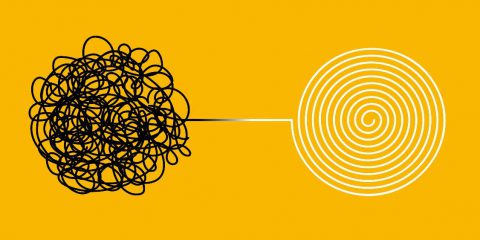Nella rubrica di Democrazia futura Riletture il direttore di Mondoperaio Luigi Covatta commenta il Rendiconto, saggio testimonianza scritto nel 2001 da Claudio Petruccioli, di cui La Nave di Teseo ha pubblicato una riedizione con un’ampia nuova prefazione dell’autore. Per Covatta la svolta della Bolognina è paradigmatica di quella che chiama la “parabola della sinistra italiana” segnata per l’appunta da “L’illusoria Exit Strategy del PCI di Achille Occhetto” di cui Petruccioli fu uno stretto collaboratore: “Era ovviamente opportuno liberarsi dalle filosofie della storia e convenire che il fine è nulla e il movimento è tutto: ma per “uscire” bisognava lasciarsi alle spalle non la fede nel “fine”, bensì proprio il peculiare modo di essere “movimento” del comunismo italiano. Bisognava lasciarsi alle spalle, cioè, il “partito nuovo” creato da Togliatti: una creatura concepita per conciliare la piena partecipazione al regime democratico – le cui regole, fra l’altro, si contribuiva a definire – con la risorsa rappresentata dal legame di ferro con l’Urss. Un’operazione acrobatica che non riuscì né ai comunisti francesi, né – drammaticamente – ai greci: e che riuscì a Togliatti anche grazie alla peculiarità della transizione dal fascismo alla democrazia che si verificò in Italia. […] Ovviamente, non è colpa di Occhetto (e men che meno di Petruccioli) se la prima Repubblica è crollata. – prosegue – : “E’ colpa semmai dei loro predecessori averla puntellata in ogni modo anche quando – nel 1956, nel 1968, nel 1978 – c’erano le condizioni per governare una transizione che durava dal 1943, pur di non mettere a rischio la preziosa eredità togliattiana”.

Nel 1987 a Claudio Petruccioli sembrava relativamente semplice “uscire dal Pci”. All’inizio di una legislatura che non lo vedeva più in Parlamento, ma membro molto autorevole della segreteria del partito, mi illustrò la exit strategy elaborata con Achille Occhetto, in un contesto in cui la perestroika ormai marciava spedita verso il suo prevedibile esito. Forse sopravvalutando il mio ruolo, mi suggerì di riferire a Bettino Craxi di non aspettarsi confluenze o alleanze. Il Pci sarebbe uscito dal comunismo non con un’abiura, ma dosando diversamente gli elementi dell’alchimia che gli aveva garantito piena legittimazione alla Corte di Salerno, e negli ultimi vent’anni gli aveva consentito di essere “di lotta e di governo”, nonché unito “nella diversità” all’Unione Sovietica. La strategia prevedeva innanzitutto che i dirigenti più anziani – i quali non potevano non dirsi comunisti – fossero “giubilati” nel senso etimologico del termine: destinati cioè a cariche istituzionali per accedere alle quali sarebbe stato necessario l’avallo delle altre forze politiche (con la conseguente accettazione senza beneficio d’inventario, da parte loro, dell’intera storia del Pci). Sarebbero però stati esclusi dal vertice del partito, che invece sarebbe stato composto – oltre che dagli attempati quarantenni riuniti attorno ad Occhetto – dagli indipendenti di sinistra, ai quali nessuno poteva rinfacciare un passato comunista. Fu così che Stefano Rodotà diventò il primo presidente del Pds. Ma l’innesto non attecchì: sicuramente per l’eterogeneità delle posizioni politiche dei compagni di strada (Rodotà, per esempio, era ostile ai referendum di Mariotto Segni, mentre altri li avevano fatti propri); probabilmente anche per la resistenza dei titolari della “ditta”, come osserverà più tardi Emanuele Macaluso nello spiegare perché “da Cosa non nasce Cosa”.

Ora Claudio Petruccioli, nel capitolo che ha aggiunto al suo Rendiconto del 2001, riconosce che invece “uscire dal Pci” è stato molto più complicato di quanto pensasse. Ma “l’errore da cui liberarsi”, probabilmente, non è solo “l’esperienza del comunismo”: neanche quella vissuta dai comunisti italiani, che a differenza dei bolscevichi “al potere non sono stati ma che ne hanno condiviso colpe ed errori, anche facendo violenza alla propria intelligenza e alla propria coscienza, per il solo fatto che il 1917 fu considerato la rottura di un sistema e il passaggio finalmente possibile a un altro sistema”.
Era ovviamente opportuno liberarsi dalle filosofie della storia e convenire che il fine è nulla e il movimento è tutto: ma per “uscire” bisognava lasciarsi alle spalle non la fede nel “fine”, bensì proprio il peculiare modo di essere “movimento” del comunismo italiano. Bisognava lasciarsi alle spalle, cioè, il “partito nuovo” creato da Togliatti una creatura concepita per conciliare la piena partecipazione al regime democratico – le cui regole, fra l’altro, si contribuiva a definire – con la risorsa rappresentata dal legame di ferro con l’Urss. Un’operazione acrobatica che non riuscì né ai comunisti francesi, né – drammaticamente – ai greci: e che riuscì a Togliatti anche grazie alla peculiarità della transizione dal fascismo alla democrazia che si verificò in Italia.
L’8 settembre forse non fu “la fine della Patria”: ma certamente segnò la dissoluzione delle istituzioni, per vent’anni innervate simbiosi da un partito ormai messo al bando e peraltro non surrogato da una dinastia in fuga dalle responsabilità (ed anche dalla dignità). Gli alleati, d’altra parte, non erano nelle condizioni di imporre all’Italia un regime change analogo a quello che avevano imposto alla Germania. Per cui fu inevitabile che al fascismo succedesse – ben oltre l’emergenza in cui il CLN aveva assunto funzioni di governo – quella che Luciano Cafagna ha definito una “partitocrazia pervasiva”: e Palmiro Togliatti – come per altro verso Alcide De Gasperi – seppe sfruttare appieno anche questa risorsa. Il “lascito fascista” che spettò al Pci, secondo Cafagna, fu quello che valorizzava “i mutamenti intervenuti con il fascismo nella ‘forma partito’, come istituzione della società di massa caratterizzata da una domanda di protezione, specifica a questo nuovo tipo di società, con la quale ormai in Italia si tendeva a considerare il rapporto sociologico con la politica”[1]. E la genialità di Togliatti fu quella di combinare anche il “lascito fascista” con la mano tesa alla dinastia a Salerno, con il legame con una delle potenze vincitrici, nonché con l’invenzione della catena De Sanctis – Labriola – Croce – Gentile, più o meno correttamente attribuita ad Antonio Gramsci e recentemente riproposta da Biagio de Giovanni: invenzione che consentì al Pci di penetrare nel senso comune del ceto colto….Il “partito nuovo”, insomma, fu uno dei pilastri di quella Repubblica dei partiti illustrata da Pietro Scoppola e poi frettolosamente rottamata come “prima Repubblica”: fino a trasformare in risorsa anche la discriminazione di cui nella sua costituzione materiale era oggetto.
La conventio ad excludendum, per esempio: alibi eccellente per ripararsi non solo dalle responsabilità di governo, ma anche dall’onere di concepire una qualsivoglia strategia delle alleanze che non fosse quella – sostanzialmente neutra – delle grandi coalizioni. Paradossalmente, però, già nel 1979 Berlinguer ignorò quel tacito vincolo di solidarietà con l’insieme del sistema politico quando evocò la categoria della “diversità” per definire l’identità del Pci. Ed Occhetto, dieci anni dopo, si mise addirittura alla testa dei rottamatori della prima Repubblica: per cui i comunisti “si mostrarono pronti a far propri concetti che sino a qualche anno prima sarebbero a loro stessi apparsi eversivi nonché degni del peggiore degli insulti: qualunquista” come ha scritto Salvatore Lupo[2].
Ovviamente, non è colpa di Occhetto (e men che meno di Petruccioli) se la prima Repubblica è crollata. E’ colpa semmai dei loro predecessori averla puntellata in ogni modo anche quando – nel 1956, nel 1968, nel 1978 – c’erano le condizioni per governare una transizione che durava dal 1943, pur di non mettere a rischio la preziosa eredità togliattiana. Colpa di Occhetto (non di Petruccioli[3]) è invece quella di aver rinunciato a governare l’ultima fase della crisi, per evitare che si trasformasse nella catastrofe che ha coinvolto anche il Pci.
Forse Occhetto prese troppo sul serio l’editoriale pubblicato da Maurice Duverger sul Corriere della Sera il 4 gennaio 1993: in cui si sosteneva che “riformare il modo di scrutinio senza riformare la Costituzione sarebbe già sufficiente a portare il governo di Roma allo stesso livello di quelli di Parigi, Londra e Bonn”, e che così si sarebbe realizzata “una unione della sinistra su basi inversamente simmetriche a quelle che l’hanno portata al potere in Francia”. Sappiamo tutti come è andata a finire.
[1] Luciano Cafagna, Una strana disfatta, Marsilio, 1996, p. 43. Si veda anche Luciano Cafagna, La grande slavina, Marsilio, 1994, p. 64; Id., C’era una volta, Marsilio, 1991, pp. 66-83. Il concetto venne ripreso da Giuliano Amato nel discorso con cui, nel 1993, motivò le dimissioni del suo primo governo davanti alla Camera dei Deputati.
[2] Salvatore Lupo, Partito e antipartito, Donzelli, 2004, p. 10.
[3] Nel numero di gennaio del 2020 di Mondoperaio Petruccioli deplora, per esempio, il rifiuto da parte di Occhetto di prendere in considerazione le proposte di Craxi dopo le elezioni del 1992.