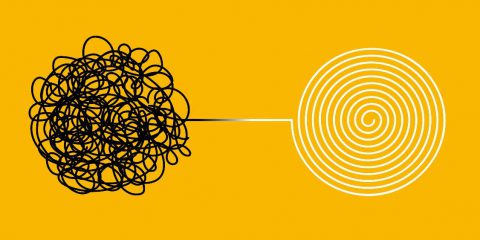Prosegue la riflessione geopolitica di questo numero di Democrazia futura con Raffaele Barberio, che dedica un lungo articolo alle relazioni Usa Cina e, tra globalizzazione e pandemia, alle guerre fredde e divisioni del mondo, osservando le differenze fra la vecchia guerra fredda USA-URSS e l’attuale conflitto fra Stati Uniti e Cina, avviato dall’amministrazione Trump in particolare contro Huawey, in cui la telefonia mobile di quinta generazione – ovvero uno standard da condividere su scala globale – è diventato il terreno di battaglia.
Il contesto
La Cina si è affermata da anni come la seconda più grande economia del mondo. Oggi è un Paese lanciato verso il futuro, fortemente modernizzato, con un altissimo livello di urbanizzazione e una dotazione di conoscenze tecnologiche che lo pongono ai vertici mondiali. Da cosa sia nato tutto ciò, anche in contro tendenza con quanto accadeva in buona parte del mondo? Questo punto di approdo è frutto di una serie di concause alla cui base vi sono un rapido processo di industrializzazione iniziato negli anni Sessanta e le riforme strutturali avviate a partire dagli anni immediatamente successivi. La marcia vittoriosa della Cina ha generato recentemente condizioni di grande tensione con gli Stati Uniti, secondo modalità che nessuno avrebbe potuto immaginare appena pochi anni fa. Nelle pagine che seguono cercheremo di capire genesi, sviluppi e possibili conseguenze di una partita che sta diventando sempre più globale.
Le ragioni dell’affermazione cinese
La Cina deve il proprio successo alle scelte politiche adottate dai leader visionari su cui ha potuto contare a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Leader che hanno spezzato la continuità con la precedente epopea maoista, guardando all’Occidente, ma senza perdere nulla della propria identità, a parte la ripulitura dai pesanti fardelli ideologici che hanno accompagnato il potere maoista. Inoltre, la Cina ha colto l’opportunità di avviare la propria crescita in un contesto internazionale tendenzialmente non ostile, contando paradossalmente anche sul supporto degli Stati Uniti e dei Paesi occidentali. E il perché è facilmente spiegabile. Le energie dei Paesi occidentali erano rivolte da tempo all’isolamento e al confronto serrato con l’URSS, il che ha creato per i cinesi proprio quella condizione di favore, proseguita anche successivamente, dopo la disintegrazione del regime sovietico. Da quel momento le attenzioni degli Stati Uniti furono infatti attratte dalla regione petrolifera del Medio Oriente. E il risultato di quel passaggio è ancora nella memoria televisiva di noi tutti. L’Iraq, il Paese militarmente più temibile della regione, è stato sistematicamente distrutto in base ad accuse (rivelatesi poi infondate) di possedere armi di distruzione di massa e il suo leader Saddam Hussein ucciso. E va qui ricordato che tutto nacque dall’invasione del Kuwait, sul quale documenti successivamente raccolti stabilirono come fu lo stesso ambasciatore americano a dare il segnale verde a Saddam per invadere il Paese, circostanza che rappresentò la scintilla da cui nacque appunto l’invasione americana. Analoghe accuse furono fatte alla Libia, il cui leader Mu’ammar Gheddafi è stato ucciso con modalità funzionali ai flussi dell’informazione televisiva mondiale. Senza alcuna difficoltà, si può affermare dire che la fine della “guerra fredda” generò nell’intera regione una instabilità tuttora persistente. L’implosione sovietica cancellò agli occhi degli Stati Uniti la presenza ultradecennale del nemico diretto. Ma nessun pugile può stare sul ring a combattere da solo e fi per questo la ricerca di conflitti portò Usa e paesi occidentali a cercare in Medio Oriente quel nemico da sostituire all’Unione Sovietica. La mancanza di un nemico “globale” indusse addirittura gli Stati Uniti e la maggior parte degli osservatori internazionali a pensare che fosse nata una nuova era, caratterizzata dalla uni-polarità della potenza americana, con una presenza indiscussa di Washington come controllore degli affari globali. E non a caso, la successiva guerra in Siria generò atti di contrasto del tutto inattesi da parte della Russia contro Stati Uniti e alleati europei, giusto per ricordare che la nuova Russia di Putin non intendeva lasciare libero il campo.
Ma torniamo alla Cina. Mentre gli Stati Uniti erano impegnati prima nella “guerra fredda” contro l’URSS e poi nei conflitti mediorientali, la Cina si trovò fuori dai radar e riuscì a svilupparsi industrialmente con un passo di crescita progressivo sempre più accentuato. Poi la Cina è rientrata gradualmente nei radar e ogni iniziativa cinese è diventata oggetto di valutazione e di analisi. E solo allora gli Stati Uniti hanno cominciato a percepire la Cina come una minaccia prima insidiosa e poi temibile. Dal freddo distacco, se non atteggiamento favorevole (in funzione antisovietica), si è passato al monitoraggio, infine all’ostilità, quella che, pur incubata sotto l’amministrazione Obama, si è manifestata apertamente con la presidenza Trump. Ed è così ripartita con la Cina quella che molti hanno definito “guerra fredda”, di cui lo scontro commerciale è stato solo una delle dimensioni del confronto ostile avviato. Il Mar cinese meridionale, una regione ricca di riserve di gas e petrolio, è oggi oggetto di grandi dispute territoriali e potrebbe diventare l’epicentro di nuove guerre. Con la sua supremazia militare sull’area, gli Stati Uniti hanno condotto e stanno conducendo manovre navali nella regione che hanno generato molte tensioni. Non a caso sta prendendo piede un certo sostegno da parte degli Stati Uniti a favore dell’India in funzione di contrasto con la Cina. In vista di tali tensioni, la Cina incrementa i budget della difesa, nonostante le dichiarazioni di pace e le preoccupazioni per assicurare la crescita economica interna, nel frattempo si arma quella diplomazia cinese che ha già risolto molte dispute territoriali ugualmente complesse: dalla restituzione di Hong Kong a quella di Macao dal Portogallo.
L’attuale scontro USA-Cina
Oggi Stati Uniti e Cina si trovano di fronte ad una serie di sfide di grande portata nelle loro relazioni bilaterali. Abbiamo visto da dove nascono le ragioni del conflitto, resta da considerare il perché. Un primo aspetto ha a che fare con la considerazione dell’altro. L’Occidente ha sempre mal interpretato la Cina. Nell’ultimo secolo le previsioni su questo immenso Paese sono andate dal collasso economico alla sua “inevitabile” evoluzione in una democrazia liberale. Il problema è che l’Occidente cerca di interpretare la Cina in base ai propri valori e alle proprie regole. Certo la Cina nel corso dei decenni è cambiata molto, nonostante l’Occidente continui a percepire la sua evoluzione in modo del tutto impercettibile. Ed è difficile interpretare la Cina con gli occhi degli occidentali che non conoscono, per ovvie ragioni, nulla del Confucianesimo, del Buddismo e del Taoismo, che sono alla base della cultura politica cinese, e non hanno idea di come queste componenti culturali, religiose e filosofiche abbiano modellato più in generale il modo d’essere dei cinesi.
Un secondo aspetto riguarda gli aspetti commerciali. Negli ultimi anni, Trump ha identificato la Cina come il principale competitor degli Usa e ha accusato il Partito Comunista Cinese di trarre vantaggi indebiti dai commerci internazionali e, nell’ultimo anno di presidenza, di non aver detto la verità sul Coronavirus, da Trump ribattezzato come il “morbo cinese”. Senza dubbio, il peso innanzitutto economico e solo dopo militare della Cina è cresciuto ad una velocità sorprendente, e questo può essere considerato come l’aspetto geopolitico più rilevante di quest’ultima fase storica a cavallo tra i due secoli, unitamente alla caduta del regime dell’Unione Sovietica del 1991 che segnò anche la fine della guerra fredda propriamente detta.
Per molti anni, l’Occidente ha fato grandi concessioni alla Cina, a partire dall’ingresso nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 2001, con l’obiettivo di aprire politicamente ed economicamente le barriere della Cina, un auspicio che si è realizzato ma non con le modalità e le aspettative previste dai sostenitori di quella integrazione. Nel 1979, la Cina aveva un’economia più piccola dell’Italia. Con l’apertura agli investimenti esteri e l’introduzione della riforma dei mercati la Cina è gradualmente diventata la seconda economia del mondo. Ed ora la Cina ha una posizione di leadership in alcune tecnologie che stanno caratterizzando l’avvio del Ventunesimo secolo come il 5G, l’intelligenza artificiale, i Big data, la medicina rigenerativa per citare alcune delle applicazioni più appariscenti che stanno accompagnando l’evoluzione tecnologica della nostra epoca.
Questo punto d’approdo ha generato le condizioni perché il mutato atteggiamento americano nei confronti della Cina si trasformasse, palesemente con la presidenza di Donald Trump, in un vero è proprio stato di sfida costante e senza esclusione di colpi tra le due potenze. L’attacco senza quartiere scatenato dagli USA nei confronti della Cina ha coinciso con il lancio della Belt and Road Initiative, un progetto colossale di collegamento logistico, commerciale e con un forte significato di cooperazione politica tra la Cina e l’Europa, con il coinvolgimento dell’intera Asia meridionale, come territorio di transito e parte integrante del progetto. È lì che potremmo collocare uno dei punti simbolici di partenza dello scontro tra Stati Uniti e Cina degli ultimi anni. Uno scontro che ha via via assunto i caratteri della guerra, pur senza sparare un solo colpo. Come in tutte le guerre, c’era bisogno di un pretesto e come in tutte le guerre, i primi ad essere colpiti sono i simboli del nemico.
Scoppia il caso Huawei
Come si sa, a differenza dei secoli passati, in cui lo stato di guerra era marcato dallo sfondamento delle frontiere del nemico, oggi le guerre si combattono e si vincono invece facendo uscire i dati fuori dal confine del paese nemico. Gli Stati Uniti hanno scatenato una guerra non dichiarata contro la Cina proprio partendo dal presupposto che quest’ultima avesse scatenato operazioni di sfondamento delle reti e degli apparati di trasmissione dati dei Paesi occidentali. Come? Attraverso Huawei, la sua società cinese più in vista sui mercati internazionali e che è anche il simbolo del trionfo tecnologico della Cina. Vediamo allora innanzitutto cosa è Huawei e perché questa azienda privata cinese è diventato il cuore dell’attacco statunitense contro la Cina. Le fortune internazionali di Huawei nascono quasi per caso. Poco più di una decina di anni fa, l’operatore di telecomunicazioni svedese TeliaSonera decise di costruire una delle prime reti di telefonia 4G in alcune città scandinave, tra cui Oslo. TeliaSonera fece all’epoca una scelta audace e inaspettata del fornitore, selezionando Huawei, una società cinese, allora quasi sconosciuta in Europa e con una piccola presenza commerciale in alcuni mercati in via di sviluppo. Ma non finì lì. Poco dopo, Huawei ottenne un altro gran risultato, ricevendo l’incarico di ricostruire l’intera rete telefonica mobile della Norvegia, precedentemente costruita dalla svedese Ericsson e dalla finlandese Nokia. Per la prima volta, esperti ed addetti ai lavori europei realizzarono che Huawei non era solo un interlocutore per soluzioni di “basso profilo”, come definite da alcuni osservatori, ma anche un concorrente delle affermate società dell’epoca capace di competere anche su qualità e prezzi. In meno di una decade, Huawei, società privata cinese è diventata la prima azienda al mondo di apparecchiature di telecomunicazioni, con un fatturato di oltre 100 miliardi di dollari, quasi 200 mila dipendenti ed operazioni in oltre 170 Paesi. Ma ciò che più conta, ai fini della nostra ricostruzione, è che Huawei è il vincitore indiscusso della corsa internazionale, lunga un decennio, per il primato nelle tecnologie 5G.
Il 5G, come è noto, non è stato sviluppato per far comunicare meglio i telefonini, tra loro ma per costituire un vero e proprio sistema nervoso centrale della società e dell’economia. Se Huawei cresce, si sarà detto Trump, allora non sarà Washington ma Pechino a raccoglierne tutti i benefici che ne deriveranno. Ecco perché il 5G è diventato il terreno di battaglia per lo scontro geopolitico tra Stati Uniti e Cina. La società cinese ha così dominato i titoli dei giornali dal 2019 come il cuore dello scontro geopolitico tra le due superpotenze. Huawei, è stato l’atto d’accusa dell’amministrazione americana, lavora per il governo cinese e per il Partito Comunista Cinese e nel vendere i propri prodotti cerca di entrare nelle reti di altre nazioni per controllarne le comunicazioni.
Viene allora da chiedersi come abbia fatto la società nata nel 1987 da Ren Zhengfei, un veterano dell’Esercito Popolare di Liberazione a raggiungere questi risultati. Il giovane Ren a 39 anni si assicurò un prestito di 8,5 milioni di dollari da una banca di Stato e iniziò l’avventura di Huawei con 14 persone di staff, come riportato in un vecchio profilo aziendale. Iniziò come importatore di commutatori per telecomunicazioni. Poi nel 1990 cominciò a produrre un proprio commutatore ed iniziò a fare considerevoli investimenti in Ricerca e Sviluppo, per produrre in proprio i prodotti da usare nell’installazione di reti. I risultati non tardarono, ma la strategia di fondo rimase la stessa. Negli anni Novanta, Huawei aveva 500 persone nella Ricerca e Sviluppo e 200 persone alle linee di produzione. E il vento cominciò a prendere la direzione giusta quando nel 1993 produsse il primo commutatore ed acquisì l’esercito cinese come primo vero cliente importante. Fu in quegli anni che il governo cinese comprese che avrebbe potuto giocare in modo diverso le proprie carte in ambito tecnologico e nel 1996 la Cina adottò una politica industriale studiata per tenere le imprese estere di telecomunicazioni lontane dal mercato domestico, il che forse favorì definitivamente Huawei. Viene allora da chiedersi a cosa si debba il successo mondiale di Huawei? Al supporto statale? Alle politiche di protezione del mercato interno da parte del governo cinese? Alla vastità del mercato interno sostenuto da una grande crescita economica?
Viene difficile riconoscere in un’unica ragione il successo di Huawei. Certo non può essere una coincidenza che il primo grande cliente di Huawei sia stato proprio l’Esercito Popolare di Liberazione, come sostengono capziosamente alcuni osservatori, ma è anche vero che il grande successo mondiale di Huawei debba essere valutato come conseguenza di una serie di fattori, tra cui brillano paradossalmente anche i passi falsi o le scelte mancate dei principali competitori occidentali.
La Cina, il 5G e Huawei
Huawei progetta, sviluppa e vende apparecchiature e reti di telecomunicazioni assieme a prodotti di elettronica di consumo. Tutti prodotti che hanno incontrato il favore del mercato, perché innanzitutto efficienti e competitivi. Ma anche economicamente convenienti. Questo ha voluto dire che gli operatori di telecomunicazioni operanti nei vari Paesi, che avevano costruito le proprie reti di 3G e 4G con soluzioni all’epoca più costose e fornite da Ericsson e Nokia, al momento del passaggio al 5G hanno scoperto che Huawei poteva offrire le medesime soluzioni, anche tecnologicamente più efficienti ma con prezzi più competitivi. E così hanno scelto Huawei. Oggi Huawei controlla il 29 percento del mercato delle apparecchiature e reti di telecomunicazioni, che sale al 34 percento in America Latina e al 43 percento nella regione Asiatico-Pacifica. Investe in media tra i 15 e i 20 miliardi di dollari all’anno di R&S, un settore che occupa circa 80 mila ricercatori. Inoltre è anche un’azienda verticalmente integrata. A differenza dei competitor europei come Ericsson e Nokia, Huawei progetta quasi tutti i componenti tecnologici di 5G che vende e usa, assieme a tutti gli altri prodotti che commercializza, compresi smartphone e computer. E sui mercati smartphone l’azienda cinese è il secondo produttore al mondo, dopo Samsung. Ora, se è vero che Huawei ha un valore simbolico estremamente alto per la Cina, è anche vero che la tecnologia cinese non è solo Huawei. La quota della Cina nei brevetti del solo 5G è cresciuta notevolmente rispetto alla posizione del 4G e porta le aziende cinesi a detenere circa un terzo delle entrate mondiali da brevetti, perfino quando le società detentrici risultano impedite a vendere i propri prodotti a seguito di misure governative nei paesi dove i loro prodotti sono usati. Secondo una recente indagine di IPlytics, le società cinesi detengono il 34 percento dei principali brevetti sul 5G al mondo, in una classifica che vede la Corea del Sud al secondo posto con il 25 percento, e al terzo posto con il 14 percento Stati Uniti e Finlandia. Seguono la Svezia all’8 percento, il Giappone al 5 percento, con Taiwan, Canada, Regno Unito e Italia a chiudere la top-Ten con l’1 percento ciascuno. Ovviamente se dalla graduatoria dei Paesi passiamo a quella delle aziende, per i brevetti del 5G troviamo al primo posto Huawei con il 15 percento, seguita da Nokia con il 14 percento, quindi Samsung con il 13 percento, LG al 12 percento e ZTE con l’11,7 percento. Mentre la prima impresa americana è Qualcomm con l’8 percento affiancata, sempre con l’8 percento, dalla svedese Ericsson, seguiti da Intel che ha il 5 percento e dietro di loro altre società, prevalentemente cinesi e giapponesi, con piccole quote. Huawei ha più brevetti di chiunque altro e chi farà 5G sarà costretto comunque a pagare royalties a Huawei.
Il 5G uno standard da condividere su scala globale
Quindi, il 5G è innanzitutto standard. E questi standard, condivisi a livello globale, sono approvati e devono essere rispettati su tutti i mercati. Tutte le reti ed i device devono conformarsi a tali standard. Ciò implica l’uso di tecnologie brevettate e sottoposte al vaglio degli organismi internazionali di controllo. Uno smartphone può avere tutte le funzioni che ha grazie a circa 250 mila differenti brevetti (o “grappoli” di brevetti). In particolare, i brevetti che devono essere usati per assicurare la conformità agli standard tecnici come quelli del 5G sono chiamati Standard Essential Patents (SEP). Ebbene qualche anno fa i SEP necessari per uno smartphone erano almeno 150 mila. Il numero dei possessori di SEP nel mondo è passato dalle poche unità dei primi anni Novanta ad oltre 100 alla fine della decade appena finita. E i brevetti presuppongono, quando usati da soggetti terzi, il pagamento di royalties o accordi d’uso di varia natura. Il produttore di chip Qualcomm, ad esempio, ricava i due terzi delle proprie entrate da royalties proprio dalla Cina, e molte di esse sono assicurate proprio da aziende cinesi, grazie all’uso dei chip della società americana da parte dei produttori cinesi di telefonini. Dal 2001 Huawei ha pagato non meno di 8 miliardi di dollari in sole royalties, 80 percento dei quali proprio a Qualcomm. Oggi il quadro sta cambiando. Huawei ha al momento il più vasto portafoglio di SEP legate al 5G, il che rappresenta lo spostamento territoriale della “posizione dominante” da Stati Uniti ed Europa alla regione asiatica e alla Cina in particolare. Nel 1998 le società americane ricevevano importi da royalties 26,8 volte superiori rispetto alle cifre versate a società cinesi da società americane. Nel 2019 il rapporto si è ridotto a 1,7 volte. La situazione si sta quindi invertendo e la Cina sta passando da utente di brevetti altrui ad elargitore di brevetti propri a favore delle aziende di altri mercati e di altre nazioni.
L’offensiva di Trump sul 5G
Da qui la decisione di Donald Trump di scatenare l’inferno, prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo e per due ragioni. La prima è che il 5G è la rete delle reti, la base di un mondo futuro ormai sempre più vicino in cui tutti gli immaginabili device tutti saranno interconnessi tra loro e unificati in un unico flusso di dati. La seconda è che Huawei è una società cinese considerata dagli Stati Uniti come subalterna allo Stato cinese o al Partito Comunista Cinese, nonostante il proprio status di società privata, in virtù della sua posizione dominante sul 5G avrebbe fatto incetta di dati destabilizzando gli Stati Uniti e progressivamente le altre democrazie occidentali. Il governo americano ha così deciso di dichiarare guerra a Huawei, tirando dietro di sé uno dopo l’altro Canada, Australia e Nuova Zelanda, che assieme alla Gran Bretagna costituiscono con gli Stati Uniti il gruppo dei 5 Eyes – uno storico cartello di condivisione delle risorse di intelligence del mondo anglosassone -. La Gran Bretagna è seguita poco dopo, obbligando gli operatori non solo a non adottare tecnologie di Huawei, ma anche a rimuovere quelle già adottate per le reti in 3G e 4G, imponendo un obiettivo che, secondo il Ceo di BT, può essere raggiunto solo in un arco di tempo non inferiore a 10 anni e con costi del tutto ragguardevoli, nell’ordine di molti miliardi di sterline.
Alle imposizioni della ruvida diplomazia di Trump sono poi seguite altre nazioni europee ed asiatiche. Ma a un certo punto, Trump ha anche varato una misura restrittiva ancor più vincolante, imponendo alle società americane di tecnologie il divieto di vendere a società cinesi, e innanzitutto a Huawei, i chip per la produzione dei microprocessori. Pensare che si possa fermare la Cina sottraendo le forniture di chip è da ingenui. È vero che per rimpiazzare quelle forniture americane con produzioni interne cinesi richiede strategie di investimenti, risorse finanziarie e cervelli. Ma la Cina ha tutto ciò che occorre e, ad oggi, è difficile capire quale sarà il punto di approdo di questa strategia della tensione e quali saranno le conseguenze delle azioni dell’amministrazione Trump o le eventuali misure di controtendenza che la nuova amministrazione di Joe Biden potrebbe riconsiderare. Quel che è apparso evidente, nella strategia di Trump, è che le ragioni della propaganda e delle esigenze politiche contingenti hanno superato spesso la linea del buon senso. Una ricerca del Financial Times appurò come i moduli di radiofrequenza dello smartphone P40 di Huawei, uno smartphone top di gamma, erano prodotti da tre società americane: Qualcomm, Skyworks e Qorvo. E così si scoprì che il divieto non copriva i prodotti di società americane realizzati all’estero, che venivano pertanto venduti regolarmente a Huawei. E così Huawei ha potuto fare incetta e acquisire buone scorte di magazzino di cui aveva bisogno. Solo mesi dopo, il Dipartimento americano del Commercio ha aggiornato il regolamento estendendo il divieto a tutti i chip e agli altri componenti elettronici realizzati con software o tecnologie americane e prodotti all’estero.
In conclusione, nessuno sa se questo tentativo di soffocare la più importante società cinese di tecnologie andrà in porto o meno. Huawei è troppo grande e in posizione fin troppo dominante nel suo stesso Paese per poter fallire. Inoltre Huawei ha un grande mercato in tutti i Paesi non allineati, che acquisteranno dalla società cinese impianti di rete, apparecchiature e strumenti di elettronica di consumo. Ma la crescita di Huawei non ha per la Cina solo un carattere di vittoria o di rivincita sul resto del mondo, ha un valore emblematico ben più significativo. La Cina è stata confinata per lunghi decenni al ruolo di fabbrica del mondo. Il “Made in China” è dilagato ovunque (in molti casi anche per indicare prodotti di qualità deludente) e i cinesi sono diventati di fatto la catena di produzione industriale di quasi tutti i marchi industriali del mondo. Qualche volta questo ruolo era anche palesemente accentuato, come nel caso di Apple, che marchiava i propri prodotti con la scritta “Designed in California – Made in China”. Ironia della sorte, oggi si diffonde sempre più l’espressione “Designed in China – Made in Vietnam” (o in altri Paesi del Sud-est asiatico), quindi con un focus territoriale e con un significato politico del tutto diversi.
Ecco perché tra USA e Cina non è “guerra fredda”
Da quanto sopra riportato, appare chiaro come lo stato delle relazioni tra Stati Uniti e Cina sviluppatesi negli ultimi 30-40 anni rappresentano un conflitto anomalo, con caratteristiche per molti versi inedite e mutevoli, anche per effetto dei cambiamenti repentini di contesto. Le cattive relazioni tra i due Paesi, mai arrivate cosi ai ferri corti dai tempi della normalizzazione delle loro relazioni nel 1979 (precedute qualche anno prima dall’emblematica e simbolica partita a ping-pong tra i campioni americani e cinesi nell’atrio dell’Hotel attiguo alla Città Proibita), sono state impropriamente indicate dai media come una nuova “guerra fredda”, sul modello di quella precedente tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Una sorta di riedizione di quella del secolo scorso, che era fondata sull’opposizione ideologica dei due Paesi, sul confronto serrato che può portare allo scontro militare da un momento all’altro, sullo scontro tra sfere di influenza in cui ciascuno dei due contendenti cerca di congelare le attività dell’altro, infine sull’offensiva diplomatica, propagandistica ed economica per aggregare Paesi alleati nel tentativo di ridurre spazi vitali all’avversario e levargli l’ossigeno.
Nulla di più sbagliato, innanzitutto in riferimento al diverso contesto economico. Nel 1950, un decennio che ha rappresentato un punto di non ritorno nel conflitto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, gli americani rappresentavano circa la metà dell’intera produzione industriale del mondo. In quegli anni, il Piano Marshall portò miliardi di dollari ai Paesi europei per la ricostruzione post-bellica, ma non un centesimo di quei soldi andò all’URSS o ai Paesi dell’Est europeo. E il livello di scambio commerciale tra USA e Unione Sovietica era del tutto trascurabile se non pressoché inesistente. L’unico vero livello di scontro tra i due Paesi era la minaccia nucleare. Quindi il confronto tra le due potenze era volutamente circoscritto: era anche un modo per esser sicuri di poterlo controllare. La guerra era quindi innanzitutto ideologica, tra sistemi politici differenti, mentre i rapporti sul piano economico erano legati a specifici casi. Infine, sotto il profilo puramente militare, si era affermato il principio della localizzazione dei conflitti in territori circoscritti e guerre regionali come il Vietnam, l’Angola o il Nicaragua. A differenza di quel confronto con l’Unione Sovietica, oggi Stati Uniti e Cina sono coinvolte in interessi sovrapposti e fondati su vicendevoli convenienze nelle attività economiche, nei commerci, nonostante le sanzioni o lo scontro sulle tariffe o qualche parola di troppo dei rispettivi governanti.
Quello della interdipendenza economica è un elemento costante nel conflitto tra Stati Uniti e Cina. Persino nell’anno della pandemia e delle guerre tariffarie di Trump, lo scambio commerciale di beni tra i due Paesi si è mantenuto alto, circa 500 miliardi di dollari all’anno, cui vanno aggiunti poco più di 100 miliardi di dollari per servizi. Senza contare che la Cina possiede oltre 1,1 trilioni di dollari di titoli del Tesoro americano e ci sono altri miliardi di dollari in azioni o fabbriche in Cina possedute, costruite o gestite (assieme a enti pubblici cinesi) da società americane. E in molti casi si tratta di fabbriche che producono beni, come l’iPhone, interamente prodotto in Cina, rivolti sia al consumatore americano che a quello cinese.
L’apertura del mercato domestico cinese, successivo all’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 2001 (sempre presentato come una chance esclusiva per i cinesi) fu quindi un vantaggio anche per le aziende statunitensi che riuscirono a disporre dall’oggi al domani di una platea di consumatori immensa, come quella cinese, in un Paese in cui le aziende nazionali non erano ancora in grado di soddisfare la domanda interna. La produzione americana ebbe un’accelerazione sorprendente, così come era peraltro già accaduto con le aperture verso Taiwan (negli anni Settanta), il Giappone (negli anni Ottanta) e il Messico (negli anni Novanta) e va anche detto che i consumatori americani riuscirono ad avere anche una sfilza di prodotti molto più a buon mercato dalla Cina, il che andò a beneficio innanzitutto delle classi medie americane. Infine, è utile ricordare che durante e dopo la crisi finanziaria globale del 2008, l’economia degli Stati Uniti uscì dal baratro in cui si era cacciata grazie agli investimenti cinesi in bond e sui mercati industriali e di servizi. Un tema, questo, che è di pressante attualità.
Secondo esperti di Wall Street che fungono da advisor del Tesoro americano, interpellati da vari media, il governo federale avrà necessita di vendere bond per un valore di 12 trilioni di dollari nei prossimi 10 anni, per finanziare il proprio debito nazionale. Tutto questo in un momento, e negli anni a venire, in cui gli acquisti da parte dei cinesi di titoli del Tesoro americano stanno restringendosi. Quegli stessi analisti si chiedono cosa accadrebbe se la Cina fermasse il finanziamento del debito pubblico americano. E tutto questo accade in un momento in cui il debito mondiale ha raggiunto livelli mai visti prima d’ora.
Ecco perché Stati Uniti e la Cina non sono in una nuova “guerra fredda”. Il loro rapporto potrebbe essere definito semmai come un “matrimonio sbagliato”, che non prevede però l’opzione del divorzio. E così rimarrà probabilmente per molti anni a venire.
Naturalmente i litigi diplomatici e le parole di fuoco sono aumentati a dismisura anche nelle piccole manifestazioni, dalle sanzioni cinesi ad un gruppo di senatori americani alla chiusura del consolato cinese di Houston, ma i due contendenti sono costretti a marciare assieme. Ma tenendo sempre tutto sotto controllo. Può darsi che questo stato di cose possa cambiare nel tempo, ma il cambiamento si misurerà in termini di anni o addirittura decenni e non di mesi. A meno che Stati Uniti e Cina non si decidano a spendere dai 5 ai 10 trilioni di dollari per ricostruire le rispettive supply chain che la struttura condivisa del commercio internazionale e dell’industria ha costruito negli anni.
Forse più semplicemente gli Stati Uniti hanno bisogno di un nemico, quello che per lunghi anni è stato rappresentato dall’URSS.
E da questo punto di vista meglio la Cina che, così per dire, Al Qaeda o il fondamentalismo islamico o un indefinito terrorismo (che tante ferite hanno lasciato nella società americana).
Poi vi sono delle indubbie simmetricità. Ambedue le potenze hanno ampi contesti di riferimento e di espressione del proprio potere. La Cina domina il Mar Cinese Meridionale, mentre gli Stati Uniti fanno altrettanto sulla regione dei Caraibi. I due Paesi hanno differenze ideologiche, ma sono differenze molto meno appariscenti rispetto a quelle presenti nel secolo scorso nel confronto tra Stati Uniti e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e in effetti, va anche sottolineato che la Cina non ha come missione l’esportazione di una determinata ideologia. Quindi, non vi è nulla della relazione conflittuale tra Stati Uniti e Cina che possa essere paragonata alla “guerra fredda” tra USA e URSS.
Molto più pragmaticamente, alle singole accuse formulate da Donald Trump e che saranno sicuramente reiterate dalla amministrazione Biden, sia pure con sfumature diverse, se il timore è che la Cina possa insidiare la proprietà intellettuale delle aziende americane o i dati dei cittadini americani, allora il governo degli Stati Uniti dovrebbe investire di più in innovazione, cybersicurezza e protezione dei dati. Perché quelle insidie hanno sempre accompagnato il confronto e lo scontro tra nazioni.
Nella “guerra fredda” nessuno dei contendenti si lamentava del furto di informazioni perpetrato dall’avversario. Si cercava semmai di essere più bravi dell’avversario e magari di anticiparne le mosse. Se poi il timore riguarda una specifica azienda, come nel caso di Huawei, allora si pone semmai, per gli americani, il problema di operare scelte di policy mirate e di sviluppare aziende e tecnologie capaci di competere con Huawei o con altre aziende tecnologiche di successo cinesi. E già, perché ad un certo punto la campagna anti-cinese di Trump, focalizzata originariamente su Huawei, si è estesa ad altre aziende di telecomunicazioni come ZTE, fino a sconfinare in altri settori come quello finanziario, con WeChat, o quello dei contenuti, con TikTok.
I sostenitori degli attacchi di Trump a Huawei, indicano a sostegno delle proprie posizioni le disposizioni del governo cinese che impone alle imprese nazionali di rispondere alle richieste del governo, il che pone il problema della fusione di prerogative e operatività tra le attività civili e quelle militari. Eppure le norme che prevedono tali circostanze sono state approvate in Cina nel 2017 e hanno usato come modello le disposizioni del tutto analoghe decise dall’amministrazione americana nei confronti delle imprese americane, anche quando operano all’estero, indipendentemente dalle disposizioni del paese ospitante. A questo proposito va ricordato che in base al Cloud Act (l’ultimo di queste norme) approvato dal Congresso americano nel febbraio 2018, l’amministrazione americana può entrare in qualunque data center di aziende statunitensi, all’interno degli Stati Uniti d’America o all’estero, e per ragioni di “interesse e sicurezza nazionale” può duplicare i dati in esso contenuti. E qui il pensiero non può che andare alla montagna di dati dei cittadini italiani ed europei ospitati nel Cloud di Amazon, Google, Microsoft, Oracle, ecc. La campagna anticinese punta il dito contro il rischio futuro di accaparramento di dati da parte di aziende cinesi, ma ignora il fatto che un accaparramento di uguale natura è fatto in tempo reale (e da molti anni) dalle multinazionali americane del digitale, i Big Tech che operano sui social, attraverso sistemi operativi o con il cloud, ecc.
E ora cosa succederà?
Alcuni pensano che il conflitto tra Stati Uniti e Cina potrebbe normalizzarsi ovvero che potrebbe accadere quanto accadde ai tempi della guerra commerciale e della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Giappone. Alla fine di quello scontro, che sembrava senza via d’uscita, si trovò un accordo che regolò tutte le relazioni degli anni successivi. Ma sembra abbastanza improbabile. A questo punto, ci sono tre considerazioni da fare, che corrispondono alle tre diverse correnti di pensiero che hanno accompagnato la disputa anticinese nell’ultimo anno della presidenza Trump. La prima era che l’attacco di Trump contro Huawei sembrava impropriamente monco, troppo chirurgico, dal momento che l’amministrazione americana sanzionò solo successivamente ZTE, con una multa da 1 miliardo di dollari, e aspettò diversi mesi prima di spostare il fuoco anche contro altre società cinesi. E allora perché assumere quell’atteggiamento aggressivo contro una singola azienda privata come Huawei e erogare solo una multa, per quanto rilevante, ad una società come ZTE controllata dallo Stato cinese, che sarebbe risultata più facilmente aggredibile dalle critiche anticinesi? In secondo luogo, c’era la corrente di pensiero dei cosiddetti falchi dell’amministrazione americana, in particolare l’allora consigliere commerciale della Casa Bianca Pietro Navarro e l’allora delegato al Commercio Robert Lighthizer, che avrebbero voluto estendere subito i divieti a tutte le imprese cinesi in qualunque settore o quasi. Infine c’era la componente che fa capo al cosiddetto Military Industrial Complex, che interpreta paradossalmente la parte delle colombe e che sostiene una opzione del tutto inaspettata: la Cina è un mercato profittevole per gli Stati Uniti, dal momento che la sola Huawei nel 2019 ha speso 19 miliardi di dollari per acquistare componentistica dalle società americane. Bloccare questo flusso di relazioni commerciali, priverebbe le aziende americane di risorse importanti e avvantaggerebbe solo i concorrenti globali delle aziende americane.
Ma intanto è accaduto altro. Donald Trump ha ceduto il passo a Joe Biden, ma non senza aver fatto ulteriori danni. E nei mesi precedenti, ovvero poco prima di lasciare la Casa Bianca, si è preoccupato di imporre il divieto di vendita di chip e semiconduttori da parte di imprese americane a favore di imprese cinesi. Non sappiamo quale sarà l’atteggiamento di Biden a tale proposito, ma intanto possiamo registrare le contromosse cinesi.
Già lo scorso anno il premier cinese Xi Jinping ha lanciato un piano da 1,4 trilioni di dollari per assicurare alla Cina la guida mondiale delle principali tecnologie entro il 2025. Un piano basato su due principi cardine: la de-americanizzazione del sistema tecnologico cinese (che vuol dire assicurarsi che tutto ciò che occorre dal punto di vista delle tecnologie sia realizzato a casa propria senza dipendenze da altre nazioni) e la “circolazione duale”, ovvero un doppio filone di risultati di ricerca e di brevetti destinati in alcuni casi al solo mercato domestico ed in altri casi alla esportazione e ai mercati esteri. E così la risposta alla fuga di Android dai telefonini di Huawei è stata la sostituzione con il sistema operativo Harmony OS della società cinese.
Qualunque cosa accada in futuro a Huawei nei prossimi mesi, appare a tutti chiaro (non solo a Stati Uniti e Cina, ma anche a Russia, Unione europea e ad altri paesi) come sia diventato prioritario, non solo per la Cina, l’obiettivo della sovranità tecnologica, della capacità di essere autonomi nello sviluppo di tecnologie, senza dipendere da altre nazioni. E in questo caso non è escluso che le conseguenze di tale processo portino addirittura condizioni di progressivo impoverimento allo stesso sistema americano, quantomeno nella fase iniziale. Ecco perché la vicenda dello scontro tra USA e Cina, tra le due principali potenze del pianeta, invita a considerare i processi di globalizzazione degli ultimi decenni e porta inevitabilmente ad una conclusione: se vogliamo avere un futuro il mondo necessita non di minore globalizzazione, ma di una più corretta globalizzazione.
La globalizzazione è stata da sempre la forza più progressiva nella storia umana. Ma se non si decide di affrontare a testa alta i suoi aspetti negativi, quantomeno quelli facilmente riconoscibili ed affrontabili, la crescita di rischi di sistema e l’insorgenza di resistenze politiche porteranno inevitabilmente al trionfo di processi di de-globalizzazione. Il che vorrà dire minore cooperazione multilaterale nei confronti delle sfide globali e alla fine un mondo più povero, meno inclusivo e meno sostenibile.
I nuovi rischi prodotti dalla globalizzazione
Come è a tutti noto, la globalizzazione ha avuto una forte accelerazione negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta, in corrispondenza con la fine del blocco sovietico, con l’apertura della Cina, con la maggior integrazione dell’Europa, con l’affermazione del NAFTA nel Nord America. E proprio in quegli stessi anni il successo del World Wide Web avviava la cosiddetta Digital Age. I risultati di questi grandi cambiamenti degli ultimi tre decenni sono stati il raddoppio del reddito pro-capite nel mondo, un esercito di 1,3 miliardi di persone sottratte alla povertà, l’aumento di 10 anni delle aspettative di vita, mentre oltre 50 Paesi hanno convertito i loro regimi in sistemi democratici, prevedendo libere elezioni. E tuttavia la globalizzazione appare meno popolare che in passato per una ragione molto semplice. Il successo della globalizzazione implica inevitabilmente nuovi rischi. L’eccesso di connettività di sistemi sempre più complessi porta alla diffusione di nuove forme di rischio oltre che di benefici. I grandi centri finanziari globali generano opportunità finanziarie, ma le reti degli snodi finanziari sparsi per il mondo sono anche la fonte dei peggiori contagi finanziari o del cybercrime ormai sempre più globali. Server, reti in fibra, sistemi di Cloud servono l’economia digitale, ma sono anche il vettore di virus digitali, fake news e disinformazione. Se crescono gli aeroporti e la logistica, aumentano inevitabilmente i rischi di traffici illeciti e a diffusione di pandemie. Maggior accesso ad elettricità e trasporti da parte della popolazione mondiale equivale a maggior inquinamento. L’uso progressivo di antibiotici migliora lo stato di salute del pianeta, ma aumenta la capacità di resistenza di germi e batteri. Il maggior consumo di plastica inquina gli oceani e ci obbliga a mangiare pesce saturo di micro-particelle di plastiche.
Non è stato il COVID-19 a far deragliare la globalizzazione, come sostengono taluni. Al contrario, la pandemia ha accelerato la sua trasformazione. Alcune forme di collaborazione, come quella in ambito scientifico, sono letteralmente esplose con la diffusione della pandemia. Anche nei settori finanziari, il flusso di capitali ha visto impegnati oltre 100 Paesi alla ricerca di supporti e risorse finanziarie contro la pandemia da istituzioni e grandi investitori internazionali. La ristrutturazione delle grandi supply chain e il ripristino di servizi e produzione industriale non fermerà la globalizzazione. Semmai la trasformerà. E la globalizzazione del futuro sarà inevitabilmente centrata nell’Asia orientale, che ha la metà della popolazione mondiale e vanta i tassi di crescita economica più alti del pianeta. Dobbiamo farcene una ragione.
Ma stanno cambiando radicalmente i contesti e gli orizzonti internazionali della politica e dell’economia. Abbiamo davanti a noi leadership meno globali e meno multilaterali. Non a caso, molte istituzioni internazionali sono alla ricerca di nuove identità e di risorse che diano legittimità e mandati per le riforme e i processi di rinnovamento di ruolo che occorre avviare. Le insufficienze della politica rischiano di facilitare l’insorgenza di nuove minacce ai processi di globalizzazione, come sottolineato recentemente da Antonio Guterres, Segretario Generale dell’ONU (uno dei soggetti internazionali maggiormente impegnato nella ricostruzione di un proprio ruolo). Le grandi industrie internazionali, che operano indipendentemente dai confini degli Stati, rischiano di diventare le prime vittime sacrificali, o quelle più appariscenti, dei nuovi nazionalismi che si registrano in politica. Tornare indietro verso lo schema di globalizzazione degli ultimi due decenni non appare essere la mossa vincente. Rischierebbe di portarci indietro in un contesto pre-pandemico, che proprio per le sue insufficienze di sistema ci ha portato dritti verso la pandemia e verso altre minacce ormai evidenti come il climate change.
Non ci sarà mai nessun muro sufficientemente alto per difenderci da pandemia, climate change, catastrofi nucleari o qualunque altra minaccia di dimensioni globali. Anche perché i muri tengono anche lontani investimenti, commerci, persone, tecnologie e bloccano quella cooperazione di cui abbiamo invece urgente bisogno per fermare le minacce e stimolare il lavoro ed una crescita economica sana. Ecco perché serve meno globalizzazione, ma una migliore globalizzazione guidata da una politica all’altezza delle minacce e di leadership adeguate. E in questo contesto, la vicenda delle relazioni fra Stati Uniti e Cina è il terreno di scontro privilegiato. Con l’augurio che possa invece essere un terreno di incontro