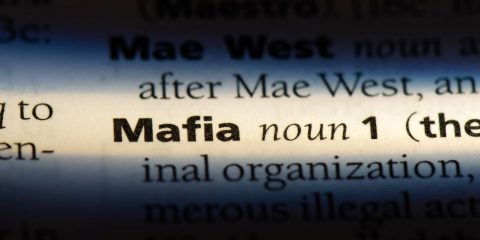Mario Pacelli, Docente di Diritto pubblico nell’Università di Roma e Giampaolo Sodano, già dirigente Rai, in un articolo “La televisione e il servizio pubblico al tempo della civiltà digitale[1]“, illustrano quella che nell’occhiello viene definita “Una modesta proposta di trasformazione della Rai in un ente pubblico”. I due autori, dopo un lungo excursus storico “Dell’EIAR alla Rai”, una volta chiarito “Cos’è stata la lottizzazione”, nel paragrafo dedicato a “La Rai nel quadro competitivo odierno” osservano come “Nel breve giro di pochi anni il servizio pubblico televisivo ha perso la sua spinta innovatrice e la propria identità fino al punto che il pubblico non avverte più alcuna differenza tra le reti RAI e quelle delle televisioni commerciali, nazionali o estere che siano”.

Partendo da questa premessa, per Pacelli e Sodano “Si tratta di riformare la Rai e di redigere un nuovo contratto tra essa e lo Stato in modo di garantire una vera riorganizzazione dell’offerta editoriale e una funzione di sostegno e promozione delle imprese audiovisive nazionali e delle istituzioni culturali”. Di qui la proposta: “Attualmente la RAI è una società per azioni con capitale interamente di proprietà pubblica (salvo una piccolissima quota della SIAE): può essere agevolmente trasformata in ente pubblico con il fine istituzionale della promozione culturale utilizzando lo strumento della comunicazione radiotelevisiva e delle nuove piattaforme per presidiare in ottica crossmediale tutte le opportunità offerte dalle nuove forme di comunicazione in rete”.
_________
Come è sempre accaduto dal 1975 ad ogni cambio di governo la RAI è tornata in primo piano nello scontro tra i partiti.
Anche il tema delle polemiche attuali è sempre lo stesso: le ingerenze politiche nella gestione dell’impresa e sulla indipendenza editoriale.
“Giorgia Meloni sarà l’ultima premier che opera una lottizzazione del Servizio Pubblico, vogliamo lavorare a una riforma complessiva per l’indipendenza, la libertà e il pluralismo dell’informazione”
ha detto Elly Schlein, ospite a Piazza pulita, una promessa tanto generica quanto azzardata per un partito come il PD che non si è mai sottratto alla pratica dell’occupazione delle poltrone a Viale Mazzini.
Nel corso degli ultimi decenni tutte le formazioni politiche, vecchie e nuove (nessuna esclusa), si sono assunte la responsabilità di decidere, non solo le regole scritte nel contratto di servizio che lega lo Stato alla RAI inquanto concessionaria di un pubblico sevizio, ma anche i nomi dei dirigenti che devono gestirla, le cosiddette nomine.
L’unica differenza tra la “lottizzazione” conseguente alla legge 103/1975 che “garantiva” attraverso il parlamento un esercizio pluralistico nella gestione di tre canali televisivi e la situazione attuale è la normativa vigente che consente un intervento diretto ed esclusivo del governo.
Tutti i cambiamenti avvenuti dopo tangentopoli hanno prodotto uno sviluppo dell’impresa? E l’intervento dei partiti ha dato un vantaggio alla RAI nel mercato televisivo? Cambierà qualcosa con i nuovi manager decisi a Palazzo Ghigi?
Tanto rumore per nulla.
La famosa egemonia culturale della sinistra ha aperto la strada alla presa del potere dei fratelli di Giorgia Meloni mentre nei salotti, tra un “Porta a porta” e un “Chi l’ha visto?”, il Funzionario di servizio cambia casacca e prepara una nuova ospitata. In definitiva sarà tutto come prima: la Rai non è in condizione di progettare alcun futuro che non sia la replica del presente cui è inchiodata dal tempo della legge 223/1990 (cosiddetta Legge Mammì) che regolamentò il duopolio RAI-Mediaset nel momento stesso in cui era superato dall’avvento del satellite. Un’impresa condannata all’occupazione dal di fuori e all’immobilismo dall’interno non può avere nessuna capacità competitiva nel contesto di un mercato globale e quindi non può che finire schiacciata da un crescente indebitamento.
Dall’EIAR alla RAI
Sono trascorsi cento anni da quando, era l’alba del regime fascista, l’8 marzo del 1923 il governo Mussolini, con il Regio Decreto n.1067, stabilisce che l’esercizio di comunicazione per mezzo di onde elettromagnetiche è riservato alla Stato. Un atto decisivo per il futuro della Radio (e poi della Televisione): fu stabilito infatti che la comunicazione ai cittadini era di proprietà pubblica.
Per esercitare questa funzione era necessaria un ente a cui affidare il servizio: il governo – dopo l’esperienza iniziale dell’Unione Radiofonica Italiana – trasforma questa azienda privata nell’EIAR, l’ente radiofonico che già dall’inizio degli anni Trenta aveva un’efficiente struttura produttiva ma soprattutto programmi che incontravano il favore del pubblico. Non era un ente del regime, ma nel regime, nel senso di essere politicamente regimentata senza per questo perdere la dimensione di impresa. Ciò ebbe notevole importanza nelle vicende successive alla fine del regime fascista.
Infatti quando la Repubblica diventa la nuova identità dello Stato due principi si sono affermati: primo, il progresso tecnologico, che aveva reso possibile la comunicazione radiodiffusa via etere, ha generato la radio, un formidabile strumento di aggregazione del consenso; secondo, il potere politico, prima e dopo la guerra, aveva deciso di servirsi di quello strumento.
Nel 1944 sulle ceneri della vecchia EIAR nasce la RAI a cui vengono conferiti, con una nuova concessione, gli stessi mezzi tecnici del vecchio ente. Al comando rimane lo stesso gruppo dirigente. La “rivoluzione” avviene all’inizio degli anni Sessanta con la direzione di Ettore Bernabei, un giovane giornalista di fede democristiana, che apre una fase nuova nella vita del servizio pubblico: i vecchi dirigenti vennero sostituiti da un management espressione del mondo cattolico, mentre cresceva l’importanza della testata giornalistica al fine della aggregazione del consenso politico. Il grande merito di Bernabei fu quello di una programmazione insieme popolare e di grande qualità, ma soprattutto fu capace di promuovere una crescita della cultura democratica ed una reale unità linguistica nella società nazionale.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 225 del 1974 dichiarò le leggi che sancivano il monopolio radiotelevisivo in contrasto con la garanzia costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della costituzione). Il Parlamento ne prese atto ed emanò la legge numero 103, con cui il controllo della RAI passava dal Governo al Parlamento, con il potenziamento della Commissione Parlamentare di indirizzo e vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Si trattò di una vera riforma del servizio radiotelevisivo che determinò una crescita dell’impresa Rai e una sua maggiore adesione alla nuova realtà del Paese. Non avvenne per caso che le reti televisive da due divennero tre, un modo per garantire la presenza all’interno dell’azienda delle tre grandi culture politiche presenti nel Paese: cattolici, socialisti, comunisti.
Cos’è stata la lottizzazione
Si è molto detto e molto scritto a proposito della “lottizzazione” della RAI: si è troppo spesso tralasciato di considerare che essa segnò non solo la fine del monopolio democristiano ma di fatto garantì il pluralismo politico nella gestione dell’azienda e nella sua informazione. Certamente lo strumento usato per perseguire questo fine non è stato esente da critiche, certamente il sistema non sempre ha premiato competenze e professionalità, certamente vi sono state contraddizioni ed errori, ma è altrettanto vero che, una volta che fosse dato per scontato il monopolio statale della radiodiffusione terrestre via etere, quel sistema non aveva alternative in un Paese democratico.
L’anno successivo, con la sentenza 202/76 della Corte Costituzionale, si apriva la stagione che fu chiamata delle “antenne libere”: la rottura del monopolio che diveniva concreta e dava il via libera alle trasmissioni radiotelevisive private anche se, al momento, in ambito locale, ma senza una normativa precisa. Si aprì così una fase di “far west” dell’etere: alla fine la partita la vinse la Fininvest di Silvio Berlusconi che, sulla scorta di quanto già avveniva negli Stati Uniti, inaugurò un nuovo modello di programmazione televisiva fatta di spot pubblicitari cuciti insieme da varietà e film.
Nessuno sembrò rendersi conto che il processo tecnologico, da un lato, e le pressioni e gli interessi geopolitici, dall’altro, avevano reso obsoleto lo schema difensivo apprestato con il monopolio pubblico della radiodiffusione terrestre: le televisioni private iniziarono trasmettendo, prima localmente, poi su tutto il territorio nazionale, attraverso la trasmissione contemporanea fatta con videocassette e, successivamente ad un decreto del governo Craxi, con la connessione per ponti radio. Poi arrivarono il satellite e con questo la prima piattaforma televisiva a pagamento promossa dal gruppo olandese Richemont e poi ceduta a Canal Plus e al magnate tedesco Leo Kirch. Il potere politico continuò a considerare immutabile il servizio pubblico delegato alla RAI, mentre il suo gruppo dirigente cercava di contrastare la concorrenza della tv commerciale scendendo sullo stesso terreno dei contenuti e della programmazione. Contemporaneamente assumevano sempre maggior potere i giornalisti e sempre più spazio una informazione che prescindeva dai telegiornali per diventare spettacolo: in questo spettacolo prendeva vita la figura nuova del conduttore, che ben presto assunse le vesti di un Masaniello interprete e guida del malessere della “gente”.
Era di tutta chiarezza che il sistema di controllo e gestione istituito con la legge di riforma n.103 del 1975 non rispondeva più alle mutate condizioni del mercato televisivo. La legge n.223 del 1990 (la cosiddetta legge Mammì) certificò il duopolio RAI-Fininvest non riuscendo a legiferare, per motivi tutti politici, sia l’avvento del satellite, sia della televisione a pagamento e tanto meno il vero artefice dello sviluppo della televisione: la pubblicità, motore dell’industria audiovisiva e non solo.
Fu un grave errore: la RAI fu costretta a difendersi sul mercato pubblicitario dalle politiche aggressive della concorrenza, mettendo da parte la sua funzione di servizio pubblico rendendo sempre meno giustificato il pagamento del canone da parte degli utenti.
L’inchiesta Tangentopoli costrinse i partiti, ormai in piena crisi, ad abbandonare la RAI al suo destino.
Agli amministratori lottizzati subentrarono personalità del mondo accademico, dell’editoria, della borghesia milanese: sembrò la situazione ideale per sottrarre l’azienda al controllo dei partiti e garantire una gestione non lottizzata. Fu una stagione di breve durata: la “Rai dei professori”, come fu denominato il nuovo consiglio di amministrazione, non ebbe il tempo di trovare un modo diverso di governare l’azienda e con le elezioni del ’94 i professori furono congedati.
Il nuovo assetto guidato dal presidente Letizia Moratti ebbe vita breve, tuttavia introdusse novità significative nelle strategie aziendali come la produzione di cartoni animati e una forte spinta alle coproduzioni internazionali, ma quando l’Ulivo, due anni dopo, vinse le elezioni, la lottizzazione riprese in grande stile fino a che, con una nuova legge, si stabilì che, essendo la Rai – dopo la chiusura dell’IRI – divenuta di proprietà del ministero dell’economia, toccava al governo nominare i vertici dell’azienda.
Siamo ai giorni nostri: è trascorso quasi un secolo di storia patria ma, come in origine, la RAI ancora oggi non è un’azienda del regime, ma è nel regime. Si “lottizza” come e più di prima ma nessuno sembra più scandalizzarsi e se a qualcuno viene in mente di “denunciare” la presenza dei partiti, e del governo, nella gestione dell’azienda, tutto si risolve con qualche stanca polemica ormai poco credibile avendo tutti i partiti, a turno, messo le mani nella gestione dell’azienda.
E’ scontato affermare che la televisione pubblica ha avuto un ruolo significativo nel passaggio dalla prima alla seconda repubblica e nel diffondere i germi del populismo e dell’antipolitica (basterà ricordare Samarcanda di Rai Tre): nello spazio lasciato libero dai vecchi partiti sono entrate forze politiche e gruppi antisistema. Cercano anch’essi il consenso e quindi occupano la RAI per utilizzarla come sempre per finalità politiche ma mostrano di non scorgere la differenza tra la propaganda, che tende ad amplificare e diffondere un messaggio e una informazione mirata ad ottenere il consenso.
Linguaggio semplice – linguaggio complesso, sono la trasposizione televisiva della bivalenza democrazia governante-democrazia governata. Lo statuto del P.N.F. (partito nazionale fascista) aveva almeno il pregio della chiarezza: il potere viene dall’alto, dal basso l’assenso. La formula appare oggi carica di suggestioni.
Ciò acquista oggi una particolare importanza in quanto nella nostra democrazia il rapporto tra elettore/eletto è profondamente diverso da quello del secolo scorso: il giudizio del cittadino sulla responsabilità politica del partito o di un singolo suo rappresentante può essere fatta valere in occasione dell’assunzione di qualunque decisione politica e non come avveniva un tempo al momento della sua elezione.
La manipolazione dei fatti e la loro strumentalizzazione vengono usate come strumenti di persuasione a volte con spericolate inchieste giornalistiche. Il dibattito politico non si svolge più in Parlamento o nel confronto tra i partiti, ma negli studi televisivi dove prevalgono i talk show che hanno come comune denominatore la rappresentazione del dibattito e la sua spettacolarizzazione più che un vero confronto tra opinioni diverse.
La Rai nel quadro competitivo odierno
Ci sono epoche in cui la storia non si ferma ed assume una velocità tale da cambiare la stessa struttura cognitiva degli uomini.
Nel breve giro di pochi anni il servizio pubblico televisivo ha perso la sua spinta innovatrice e la propria identità fino al punto che il pubblico non avverte più alcuna differenza tra le reti RAI e quelle delle televisioni commerciali, nazionali o estere che siano.
E’ potuto così accadere che negli ultimi venti anni l’azienda sia andata progressivamente svuotandosi di contenuti restando ancorata a vecchi modelli di palinsesto non più rispondenti alla domanda dei telespettatori che sempre più “costruiscono” un proprio palinsesto scegliendo nelle tante reti i prodotti più graditi.
In questo contesto, mentre si alternavano al governo destra e sinistra, il mercato televisivo nazionale è invaso da sette tra i più grandi gruppi editoriali americani: oltre a Comcast (il più grande operatore americano della televisione via cavo che si è aggiudicato la creatura di Rupert Murdoch (Sky)) Viacom, Fox, Liberty Media, Hearst, Disney, Paramount, per non parlare dei due nuovi protagonisti, Netflix e Amazon. E’ un nuovo mercato in cui la Rai è spinta ai margini mentre Mediaset cerca nuove alleanze fuori dai confini nazionali. Ma con scarso successo.
La Rai, priva di un gruppo dirigente all’altezza della sfida, ha rinunciato a svolgere il suo ruolo:incapace di una strategia d’impresa diversa e non assumendosi la responsabilità di un progetto editoriale conforme alla sua funzione di servizio pubblico, finisce per mandare in onda prodotti ideati e distribuiti casualmente e certamente non in grado di competere con la concorrenza internazionale. Ciò ha contribuito in modo significativo, oltre che ad un impoverimento culturale e progettuale dell’azienda, alla crisi di valori della comunità nazionale.
Oggi la comunicazione ed i suoi strumenti sono divenuti parte di noi stessi ed è ciò che pone più di prima il problema delle garanzie, delle regole.
Non è in discussione la maggiore libertà che l’uso dei media ha introdotto mettendoci a contatto con il mondo intero, con le diverse culture, le diverse lingue, le diverse storie, ma anche con la forza dei contenuti e dei messaggi che essi veicolano e che possono far crescere e sviluppare la personalità individuale e la comunità, evitando un regresso verso forme e comportamenti incentrati sulla violenza, sulla prevaricazione, sull’uomo oggetto e non persona che riporterebbero ai periodi più bui della storia.
Il problema etico dei media vecchi e nuovi e dei valori veicolati è che essi non possono essere che quelli dell’uomo e dei suoi rapporti con il mondo che lo circonda, appartenente ad una comunità che ha la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura e che ha in essa le sue radici e la sua identità. Ciò non significa esclusività di quei valori: ma riconosciuta dignità di esistenza a tutti quelli di individui e gruppi aventi tradizioni storiche, culturali e religiose diverse dalle nostre.
Valori forti ma anche rispetto di culture e tradizioni diverse, tutela dei diritti fondamentali della persona e di tutte le persone e quindi garanzia di pluralismo.
Pensare di risolvere il problema dei limiti attraverso norme giuridiche che tendono a rendere assoluti valori relativi è estremamente pericoloso. Molto si può fare e si deve fare definendo in modo rigoroso le responsabilità del management che gestisce gli strumenti della comunicazione e quelli della comunicazione televisiva in primo luogo.
La responsabilità di quanto è accaduto e sta accadendo è un po’ di tutti e di nessuno, conseguenza com’è di un’ormai troppo lunga disattenzione al problema dei contenuti del servizio pubblico televisivo: per quanto possa sembrare paradossale anche la sua definizione è stata finora scarsamente approfondita.
La nostra proposta
La natura pubblica della Rai, impresa alla quale il sevizio è affidato, è sembrata garanzia sufficiente ai fini della corrispondenza alle esigenze pubbliche della programmazione.
Il punto di snodo è stato individuato nella nomina del Consiglio di Amministrazione dell’azienda, demandata a soggetti pubblici in funzione della tutela degli interessi generali.
Non ci si è resi conto che questa costruzione è meramente teorica e non priva di inconvenienti. Poteva funzionare in uno scenario largamente compromissorio, dove il pubblico era la conformità agli interessi politici prevalenti che esprimevano il Cda e ad una cultura televisiva che di quegli interessi, per convenzione e spesso per convenienza, era espressione. Oggi il servizio pubblico è ancorato alla maggioranza politica di governo mentre dovrebbe corrispondere ed esprimere la complessa realtà nazionale e le consonanze e le dissonanze esistente all’interno di essa.
Occorre una legislazione che vada oltre il governo della Rai: sono necessarie regole nuove per il sistema nel suo complesso, dal digitale alla pubblicità, dalla natura delle reti nazionali ai produttori/distributori internazionali e in questo contesto una nuova missione del servizio pubblico in grado di ridare legittimità al pagamento di una tassa per finanziare l’espletamento del servizio.
Si tratta di riformare la Rai e di redigere un nuovo contratto tra essa e lo Stato in modo di garantire una vera riorganizzazione dell’offerta editoriale e una funzione di sostegno e promozione delle imprese audiovisive nazionali e delle istituzioni culturali.
E’ spaventosa la moria delle librerie, lo chiusura delle sale cinematografiche, i teatri che non possono andare avanti, l’asfissia delle orchestre, gli enti lirici che sopravvivono a stento, i musei grandi e piccoli che non possono permettersi mostre ambiziose per mancanza di fondi, i siti archeologici abbandonati a se stessi. E’ un’emergenza nazionale. La risposta non può essere quella delle tradizionali pratiche assistenziali delle sovvenzioni che il Ministero dello spettacolo continua a praticare.
Lo Stato ha la proprietà della Rai: ne faccia il centro motore per lo sviluppo del patrimonio culturale nazionale con la missione di sostenerlo in tutte le sue espressioni anche legando la governance della società ai grandi centri culturali del Paese: se la Banca d’Italia è la banca delle banche, da esse posseduta, perché la Rai non può divenire qualcosa di analogo per la cultura del nostro Paese?
Attualmente la RAI è una società per azioni con capitale interamente di proprietà pubblica (salvo una piccolissima quota della SIAE): può essere agevolmente trasformata in ente pubblico con il fine istituzionale della promozione culturale utilizzando lo strumento della comunicazione radiotelevisiva e delle nuove piattaforme per presidiare in ottica crossmediale tutte le opportunità offerte dalle nuove forme di comunicazione in rete. La nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione potrebbero essere affidate ad istituzioni culturali (accademia dei lincei, consiglio nazionale delle ricerche, accademia d’arte drammatica, centro sperimentale di cinematografia) e al Ministero dei beni culturali.
La meta finale deve essere una Rai che utilizza i duemilacinquecento milioni di euro di ricavi da canone e pubblicità per sostenere il cinema, il teatro, gli enti lirici, le imprese audiovisive, l’editoria, i siti archeologici, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, attraverso l’acquisto dei diritti di utilizzazione, erogando contributi a fondo perduto sui progetti, assegnando premi di qualità ai produttori di cultura e alle organizzazioni culturali in un piano organico predisposto in base a rigidi standard di qualità. Ciò potrà contribuire ad una forte innovazione dell’offerta televisiva, che riscopra la tv in quanto capacità di armonizzare generi, prodotti, intelligenze, una televisione dialettica che non ha bisogno né di santoni né di imbonitori, ma di manager con la patente come diceva Karl Popper.
E’ questo, se ben si riflette, il senso più autentico, perché aggiornato, del servizio pubblico che non può continuare ad essere inteso come obbligo della comunicazione istituzionale, o come messa in onda di trasmissioni celebrative, e neppure di una qualsiasi piattaforma o impresa televisiva produttrice di varietà: troppo poco per giustificare oggi il canone-tassa.
Il tempo disponibile è molto limitato: già si staglia all’orizzonte il 6G, un sistema su scala mondiale ancora più rapido e di maggiore portata nella propagazione delle immagini. Nel 2025 l’ITU, la struttura dell’Onu a ciò preposta, procederà all’esame della distribuzione delle frequenze dei diversi Paesi, e nuovi interlocutori si affacceranno alla ribalta. Gli impianti di radiodiffusione, ovvero i trasmettitori e i ripetitori televisivi, oggi un’arma forte della Rai, perderanno gran parte della loro importanza. Uno stesso programma televisivo potrà essere diffuso in molte lingue, come avviene del resto già oggi, superando la barriera linguistica della fruizione mondiale di un prodotto televisivo. E’ lo scenario prossimo venturo.
L’avvento delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale AI, inoltre, sta rivoluzionando sia la produzione di contenuti sia la loro forma. Questo non riguarda esclusivamente le professioni del mondo dei media, le loro condizioni creative e produttive, la loro autorialità. Quello che cambia è il rapporto tra contenuto e fruitore e tra la fonte e la società stessa. Senza una chiara funzione democratica dei media, infatti, ciò che decade, in primo luogo, è la struttura stessa della democrazia.
Proprio in tale campo, quindi, il servizio pubblico è chiamato a sviluppare sperimentazioni produttive e comprensione dei nuovi impatti, sociali e culturali, che le produzioni supportate dalle applicazioni AI Generative produrranno nelle società nei prossimi anni. È proprio qui, in questi ambiti, che il ruolo di un servizio pubblico non rinchiuso a perpetrare ciò che fu il suo ruolo nel passato, deve riscoprire il senso di una sua stessa esistenza. È nel mondo del grande salto verso la nuova generazione tecnologica che il vecchio ruolo pubblico può e deve rimettere in campo le vecchie radici che gli hanno fatto attraversare l’intero Novecento.
Per fare tutto ciò basta poco: un semplice provvedimento legislativo, un atto di coraggio che sarà utile vedere chi “oserà” fare nel monoteismo culturale e legislativo imperante.
[1] Anticipato sul magazine digitale www.ilmondonuovo.club.