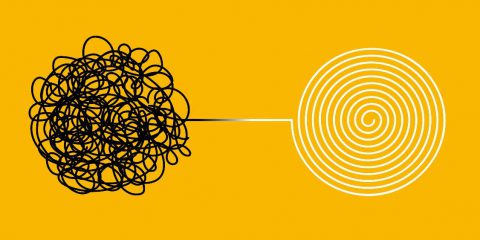Nella rubrica di Democrazia futura dedicata ai Slow media, ossia al piacere per l’orecchio fine e per l’occhio attento di fruire lentamente – ovvero controcorrente – e pienamente dei programmi offerti, abbiamo ripreso una parte di un saggio sui documentari e le inchieste di RadioRai, scritto nel 2011 come originale contributo alle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia da Paolo Morawski e Raffaele Vincenti dedicato a “La forma e lo stile del radio-documentario”, al contempo un genere e un’arte e tecnica sonora che può essere considerato l’antesignano dei nuovi radio reportage in Podcast.

La definizione del radio-documentarista e del genere radio-documentario è fluida. A seconda dei periodi si è preferito parlare di “servizio giornalistico”, “documentario giornalistico”, “inchiesta radiofonica”, “fonografia”, “radio-montaggio”, “indagine storico-giornalistica”, “giornalismo investigativo”, “diario del presente”, “incontro al microfono”, “fotografia sonora”, “film radiofonico”, “audio-documentario”, “viaggio”, “itinerario”, “impressione”. E gli autori sono stati di volta in volta definiti come “radiocronisti”, “giornalisti radiofonici”, “reporter”, “esploratori del reale”, “detective della realtà”, addirittura “mentitori sonori”. Come l’acqua ha la forma del contenitore, così il radio-documentario varia in funzione di precisi limiti: durata dell’opera (lavorare su dodici minuti o un’ora fa una bella differenza), giorno di trasmissione, collocazione nella griglia oraria, canale di diffusione, pubblico di riferimento, tempi di realizzazione, budget e supporti tecnici a disposizione, ecc. Tutto il resto è libertà, estro creativo dell’autore/regista. Scriveva in ambito universitario Costantino Granella negli anni Sessanta: «Il documentario è la radio composizione più complessa … riflette naturalmente la persona del radiocronista che lo realizza … porta la firma dell’intelligenza di chi lo ha faticosamente elaborato, ne rivela la fantasia, gli stati d’animo, i sentimenti, le passioni. Un documentario è sempre firmato dal suo autore [il quale] non si limita ad essere un diligente attento annotatore di fatti, ma può aspirare a qualcosa di più: creare un’atmosfera, progettare e realizzare un’originale architettura di volumi e di piani, che per essere soltanto fonici possono avere uguali meriti di una poesia, di una scultura, di una composizione musicale o pittorica … il radio-documentario è fino ad oggi, nel giornalismo radiofonico, la più compiuta e valida creazione». Qualche anno fa il giornalista Giuseppe Mazzei definiva così il fascino del reportage radiofonico: «È una descrizione della realtà col metodo della favola: la parola, il suono, il rumore, il silenzio si mescolano e creano un mondo fantastico».
La plasticità del radio-documentario come tipologia di programma non significa assenza di coordinate, di criteri ed elementi qualificanti. Si ha un documentario quando dalla vita “vera” si riesce a ricavare una vitale forma d’arte. Un buon documentario radiofonico è tale quando riesce a organizzare una materia sonora complessa, almeno parzialmente raccolta “sul posto”, in un’opera semplice, unica, autentica. Laddove per “semplice” s’intende la capacità di tener desto l’interesse dell’ascoltatore e di suscitare nella sua mente emozioni, pensieri, efficaci e vivide “immagini”. Detto in altre parole, la qualità di un audio-documentario è proporzionale non solo e non tanto alla qualità delle informazioni che veicola, bensì alla cultura e forza immaginativa che scatena, senza limiti di spazio e di tempo. “Buon” documentario vuol dire che l’amalgama tra qualità dei contenuti e dei messaggi, scrittura e arco della narrazione, fattori estetici, linguaggi sonori e innovazione tecnica, punto di vista dell’autore e patto con l’ascoltatore funziona. La “semplicità”, in sostanza, appare essere un punto di arrivo. più che di partenza.
Il radio-documentarista ha una relazione intensa e unica con la poesia del quotidiano, con la “realtà”, sebbene, secondo la giornalista svizzera Anik Schuin: «Alla radio – come in altri campi – dire quello che è reale significa ricostruirlo, dunque interpretarlo». Il radio-documentarista instancabilmente rincorre la “verità” sonora cercando di renderla «più vera del naturale». Egli è una figura a metà strada tra il fonico e l’artigiano, tra l’orefice e il rumorista. Ha dalla sua l’empatia dell’uomo che si interessa all’uomo e la distanza del- l’etologo che studia animali o insetti sociali. Per esprimere al meglio la sua personalità e raggiungere i suoi obiettivi artistici il documentarista ha a disposizione una ben equipaggiata cassetta degli attrezzi e molti trucchi del mestiere. Cominciamo dalla sigla. Quella iniziale può essere breve o lunga, in un solo blocco o in più parti, costruita in modo tradizionale (annuncio senza o con musica, in sottofondo o a stacco; annuncio con rumori o effetti) oppure articolata secondo una complessa architettura: collocata (solo) all’inizio o (anche) a programma (ben) avviato (persino a 10-15 minuti dall’inizio).Titoli (di solito brevi) e sottotitoli normalmente dicono l’essenziale, talvolta svelano le regole del gioco e rivelano le intenzioni dell’autore. Dopo la sigla, per introdurre il tema, si può ricorrere a un intervento iniziale pronunciato dall’autore stesso o letto da uno speaker. Oppure si può entrare subito nel vivo con rumori ambientali o proporre le prime testimonianze. La radio, si sa, «riscatta l’infinita varietà e bellezza della voce umana».
Tradizionalmente la predominanza delle voci maschili nei radio-documentari è netta. Pertanto ogni voce femminile acquista una sua originale rilevanza. La voce narrante tende a parlare – si perdoni il bisticcio – un parlato-letto, semi-spontaneo, talvolta recitato (come nei radiodrammi), talora difficile (come nei programmi culturali), in certe circostanze chiaramente letto (speaker), generalmente di stampo giornalistico (stile radiogiornale), a volte improvvisato a braccio (nelle interviste). A seconda dell’effetto che vuole creare e del suo stato d’animo, il narrante assume una voce poetico-evocativa, impersonale o coinvolta, distante o partecipe. In linea molto generale è dall’impostazione e dal tono del trasmesso che l’ascoltatore capisce subito che si trova in presenza di un documentario. Come se il documentario avesse un timbro immediatamente riconoscibile, vuoi per la cura della lingua, vuoi per la capacità di combinare fra loro testi scritti e parlati spontanei. L’autore può non essere l’intervistatore: allora le interviste intercalate nel racconto sono realizzate da altri. Nei documentari di Guido Piovene, ad esempio, lo scrittore scrive i testi, una seconda persona li “recita” e una terza o quarta persona raccoglie le testimonianze sul campo per “colorare” le sue osservazioni scritte. L’autore e/o la persona che realizza le interviste ha molti modi di proporsi: introducendo la puntata o l’intervista, dando spiegazioni, descrivendo la situazione, identificando di volta in volta chi parla, traducendo una lingua straniera, collegando tra loro i diversi momenti, commentando e facendo considerazioni – in breve essendo molto presente. Oppure può letteralmente scomparire eliminando le domande e lasciando nel montaggio solo le risposte, delegando inoltre ad altre voci (in genere la voce off di uno speaker, ma può trattarsi anche di un intervistato) la funzione di voce narrante. Tra questi due estremi – presenzialismo, invisibilità – c’è una vasta gamma di possibilità per l’autore.
Capita spesso che le voci narranti e gli speaker leggano testi di accompagnamento che rappresentano esempi di ottimo giornalismo, talvolta di ottima letteratura, in quanto di norma scritti in un italiano colto, elegante, seducente. All’ascolto, un’intervista può essere basic (domanda, risposta) oppure articolata (l’intervistatore interagire con l’intervistato).Un radio-documentario ha molti protagonisti: l’autore (o gli autori), le testimonianze (diretti interessati, esperti), il sonoro ambientale, voci e suoni d’archivio. Frequente è la lettura di brevi estratti letterari per sostenere un’idea o aprire uno spazio mentale. Solo col tempo e assai di rado si è fatto ricorso a forme di fiction teatrale (attori). Sempre più frequente è l’inserimento in un documentario radiofonico di brani audio estratti da un film o da un altro programma radiofonico (la citazione nella citazione). Nei primi anni, la regola non scritta del radio-documentarista “politicamente corretto” vuole che nel programma si incrocino interventi di un vasto spettro di rappresentanti sociali (dal camionista all’ingegnere all’amministratore, dal pescatore al vescovo all’avvocato – per intendersi). Più l’intervistato è “altolocato”, più egli tenderà – specie nei primi decenni – a leggere le sue risposte. Ciò fa supporre a chi ascolta che prima di arrivare alla registrazione ci sia stato un lungo lavoro preparatorio. Delle ricerche che il documentarista fa prima di “scendere in campo” non si parla mai. Peccato.
Agli albori della storia del documentario come genere, gli autori evocano assai spesso i “ferri” del proprio mestiere. Chiamano in causa il microfono, il registratore, le apparecchiature di registrazione, il nastro magnetico. Gli strumenti meccanici diventano così protagonisti dell’inchiesta e dell’opera finita. Il microfono che «entra per la prima volta nella storia della radio in questo o quel luogo», il registratore che viene «spento» o «acceso» o anche «nascosto», l’autore che «riascolta» il materiale raccolto e via dicendo. Indicazioni, tutte, che servono a sottolineare la novità dei tempi e la forza della radio, a esaltare il proprio lavoro e, pure, a marcare una distanza tra l’autore e l’oggetto documentato. Per la generazione dei “vecchi” è difficile immaginare un radio-documentarista senza il suo Nagra in spalla, il registratore portatile altamente professionale dotato di un microfono a filo, che necessitava di cataste di bobine stipate in tasca e nella borsa. Negli anni Cinquanta i nastri magnetici divennero più fini, permettendo una magnetizzazione più profonda e una durata del nastro maggiore. Il Nagra fu brevettato nel 1951 dallo svizzero di origine polacca Stefan Kudelski (nagra, in polacco, significa “registrerà”). Nel 1952 era già in dotazione a Radio Luxembourg. La Rai ne ordinò cento modelli nel 1959 in vista dei Giochi olimpici. Oggi la tecnologia digitale offre registratori e microfoni in miniatura, senza nastri. Il radio-documentarista non è più riconoscibile dai suoi attrezzi. Dopo la registrazione, l’asse portante del documentario è il montaggio, lavoro “invisibile” di taglio e cucito creativo che non deve essere percepito da chi ascolta (altrimenti qualcosa stride). Il montaggio è una manipolazione dichiarata dalla quale dipende “quasi tutto”, a cominciare dalle scorciatoie narrative, dalle contrazioni temporali del racconto. È il “momento della verità”, in cui è meglio essere almeno in due a confrontarsi. La qualità del singolo radio-documentario è data, infatti, anche da accorgimenti tecnici: stacchi e attacchi a secco, musica o parlato che vengono sfumati, dissolvenze e assolvenze, sottofondi, trasparenze, sovrapposizione di più “piste” o livelli sonori, isolamento e messa in risalto o associazione di singoli elementi, ripetizioni, distorsioni, echi. Nella concatenazione dei blocchi sonori (A, B, C, D) prevale di solito un andamento lineare (A+B+C+D). È però possibile procedere per incastri successivi, alternati o ritmici (per esempio: AB+AC+AD+BC+BD oppure ABC+ACB+CBA+BAC). La soluzione di volta in volta migliore, tuttavia, non è data da formule matematiche ma da come i contenuti e gli equilibri sonori s’innestano gli uni sugli altri creando l’architettura e il ritmo voluti. L’ideale, secondo i maestri del documentario, è registrare pensando al montaggio. Il numero di testimonianze conta. Più numerose sono le voci, maggiormente ricco è il racconto, ma non va sottovalutato il fascino della voce sola quando è capace di trascinare chi l’ascolta. Non sempre le voci vengono identificate, specie quando si vuol dare all’ascoltatore la sensazione di trovarsi sul posto, esaltando le sonorità ambientali. Invece un esperto, per definizione, quale che sia, ha perlomeno un nome o una qualifica. Capita che a intervistarsi vicendevolmente siano due o più intervistati con effetti di giochi di specchi. Per l’immediata comprensione di ciò che viene detto non è secondario se chi interviene parla in dialetto, ha forti inflessioni locali, usa espressioni gergali. La musica: può essere tanta o poca, limitata alla sigla oppure inserita nel corpo del documentario. Può avere una funzione decorativa, di accompagno, di alleggerimento. Specie dopo un par- lato lungo si delega alla musica un ruolo distensivo, che il brano scelto abbia attinenza o meno con l’argomento trattato. Talvolta si usa la musica come sottofondo al parlato, in altri casi essa ha una funzione didascalica, illustrativa, al fine di identificare la situazione (per esempio: cori alpini in un ambiente di montagna). Ma ci sono radio-documentaristi che non usano fare ascoltare musiche, solo stacchi musicali/sonori, anche brevissimi, di pochi secondi, allo scopo di imprimere un ritmo o di voltare rapidamente pagina. Quella del ritmo è una preoccupazione costante. La scansione dei tempi varia in funzione della durata complessiva dell’opera. Un radio-documentario che dura quarantacinque o cinquantadue minuti avrà ritmi più distesi e un micro documentario di dodici minuti ritmi sempre serrati? Di certo, il gusto odierno aborrisce lentezze, pause, silenzi-stress da vuoto. Ci sono autori che si servono della musica per continuare il racconto in altre forme (per esempio commentando le parole di una canzone o facendo diventare il brano musicale parte del racconto). In genere gli effetti sonori preconfezionati non vengono più usati dai radio-documentaristi. Forte è invece la tendenza a utilizzare, al posto di musiche “pulite” (cd), musiche “sporche”, registrate dal vivo, per strada, di “seconda mano” per così dire. O, addirittura, rumori al posto delle musiche, oppure in combinazione con esse. Per esempio: un tetto di lamiera sballottato ritmicamente dal vento, il contesto sonoro di un fiume, un aereo o un treno che passa.
C’è una scuola di pensiero molto attratta dall’equivalente, in ambito radiofonico, dell’objet trouvé in campo artistico. Nel secondo caso si tratta di un oggetto comune (sasso, bastone, rifiuto, ruota di bicicletta) trovato casualmente, esposto in quanto opera d’arte oppure usato come elemento per comporre un quadro o una scultura (un procedimento molto amato dai surrealisti). Nel caso della radio si tratta di un suono o di un rumore comune registrato in esterno, quindi preso dal quotidiano, che nel montaggio viene elevato al rango di “protagonista” (in quanto rumore musicale o testimonianza sonora).
Per la stessa logica, talvolta le parole o frasi straniere non vengono tradotte perché, più della trama, importa la qualità sonora o, meglio, il valore di atmosfera e il richiamo all’alterità che esse comunque esercitano. Come punto di partenza c’era la troupe, la Radiosquadra: il giornalista/reporter/autore, la redazione, il fonico per le riprese esterne, la camionetta 1100 dell’Eiar per trasportare le apparecchiature, quindi l’ascolto e il montaggio con il tecnico di studio, il responsabile delle musiche, il regista. Come punto d’arrivo c’è l’autore che fa tutto da solo in un ambiente completamente digitale. One man band.
Il radio-documentario esige tempo. Un certo tempo. Per essere realizzato. Per essere ascoltato.
Nota a fine testo
(1) Testo tratto da: Cento voci dall’Italia. I documentari e le inchieste di Radio Rai, (1944-2011), Ricerche e testi a cura di Paolo Morawski e Raffaele Vincenti, con una prefazione di Paolo Garimberti, “Per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia. RadioRai come luogo della memoria nazionale”, Roma, Rai Eri, 2011, pp. 146-153. Il volume comprendeva un DVD-ROM con 100 radiodocumentari con file audio per la durata complessiva di circa 56 ore.