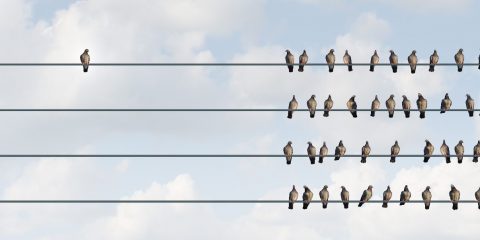Nella rubrica Memorie nostre Guido Barlozzetti offre un ricordo di Lina Wertmüller, “che poi era Arcangelina Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, figlia di un avvocato che veniva da Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza e aveva una radice in una nobile famiglia svizzera […]. un cognome , lungo come poi i titoli dei suoi film”. Nell’articolo “Il cinema di Giamburrasca”. Barlozzetti osserva come con iolneorealismo e la commedia all’italiana “Lina non aveva e non voleva avere nulla a che spartire, lei “ribelle” per carattere, “discolo”, “scugnizzo”, saltava al di là di qualunque steccato e delle etichette con cui venivano presidiati, a cominciare dalla categoria dell’impegno e dalla pregiudiziale femminista. Corpi contundenti agitati contro una regista che raccontava storie iperrealiste, per non usare il termine abusato di “grottesco”, dove l’ironia saltava di grado e costruiva caratteri esasperati nelle differenze e dunque paradossalmente presi in un gioco irresistibile di azioni-reazioni, infilati in situazioni estreme e/o in un tourbillon di sciagure e disgrazie che avessero al fondo le differenze di classe, tra il sottoproletariato e la borghesia, o lo scarto fra il Nord evoluto e moderno e il Sud irrimediabilmente istintuale, allupato e mafioso. Tutto messo nel mixer vorticoso del rapporto tra maschio e femmina, con tutti i risvolti di dominio e soggezione e quasi sempre all’insegna di una lotta per la pura e semplice sopravvivenza, della moralità e di chi se la può permettere ne parliamo un’altra volta”.
________________________________
Ha fatto discutere e parecchio Lina Wertmüller, che poi era Arcangelina Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, figlia di un avvocato che veniva da Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza e aveva una radice in una nobile famiglia svizzera. Lo ricordiamo, così togliamo subito di mezzo tutte le curiosità sul cognome, lungo come poi i titoli dei suoi film.
Hanno fatto molto discutere lei e il suo cinema, e la sua scomparsa è un’occasione, oltre che per ricordarla, per capire anche quali siano state le tracce che ha lasciato e i motivi che l’hanno imposta per una differenza indiscutibile rispetto al panorama circostante, che poi sono gli stessi per cui le polemiche l’hanno bersagliata. Un’immagine su tutte, Nanni Moretti che in Io sono un autarchico (1976) quando viene a sapere che l’Università di Berkeley ha pensato di dare una cattedra di cinema alla regista di Pasqualino Settebellezze, non finisce più di sbavare. Per tacere di certe “cupole culturali” e di Goffredo Fofi che la bollò come “L’artista dell’era di Craxi”.
Polemiche lontane, segnate dal pregiudizio dell’ideologia e che rivendicavano sul cinema italiano l’imprinting del neorealismo e, anche lì con qualche sufficienza, della commedia all’italiana. Tutta una tradizione con cui Lina non aveva e non voleva avere nulla a che spartire, lei “ribelle” per carattere, “discolo”, “scugnizzo”, saltava al di là di qualunque steccato e delle etichette con cui venivano presidiati, a cominciare dalla categoria dell’impegno e dalla pregiudiziale femminista. Corpi contundenti agitati contro una regista che raccontava storie iperrealiste, per non usare il termine abusato di “grottesco”, dove l’ironia saltava di grado e costruiva caratteri esasperati nelle differenze e dunque paradossalmente presi in un gioco irresistibile di azioni-reazioni, infilati in situazioni estreme e/o in un tourbillon di sciagure e disgrazie che avessero al fondo le differenze di classe, tra il sottoproletariato e la borghesia, o lo scarto fra il Nord evoluto e moderno e il Sud irrimediabilmente istintuale, allupato e mafioso. Tutto messo nel mixer vorticoso del rapporto tra maschio e femmina, con tutti i risvolti di dominio e soggezione e quasi sempre all’insegna di una lotta per la pura e semplice sopravvivenza, della moralità e di chi se la può permettere ne parliamo un’altra volta.
Lina, una personalità forte nella vita e sul set, le sue rivincite se le è prese, paradossalmente più oltre oceano che dalle nostre parti. Fu proprio per Pasqualino Settebellezze che nel 1976 ricevette tre nomination all’Oscar (film straniero, regia, sceneggiatura) oltre a quella per Giancarlo Giannini per il protagonista maschile, per poi ricevere una statuetta alla carriera nel 2019 dalle mani di Sophia Loren e Isabella Rossellini e, in quell’occasione, chiedere all’Academy di cambiare nome al premio, da Oscar a… “che so? Anna!”.
Vale la pena ricordare la motivazione di quel riconoscimento, l’aver usato “l’arma della cinepresa”. E in effetti questo con il cinema ha fatto, ha cavalcato e esasperato le contraddizioni di una cultura, di una mentalità e di una società, Torino industriale e la Sicilia dell’onorata società con il sottoproletario che finisce mafioso in Mimì metallurgico ferito nell’onore, amante al Nord e moglie al Sud; l’anarchico che parte da Milano per assassinare il Duce, s’incarta con una prostituta e si sveglia tardi la mattina dell’attentato, salvo poi finire ammazzato dai fascisti in Film d’amore e d’anarchia (1973); il marinaio comunista che si ritrova solo con la “battona industriale” sull’isola di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (1974) e la sottopone a un truculento e triviale dominio sadomaso, e Pasqualino Settebellezze, lui, il guappo che passa da un manicomio criminale alla campagna di Russia al lager dove diventa complice di una kapò e fa ammazzare i compagni, torna a casa e si guarda allo specchio per concludere che “Sì, sono vivo”…
Sono i marchi di riconoscimento di un cinema, legato ai volti, ai corpi e alle voci di Giancarlo Giannini e Mariangela Melato e già di questa alchimia bisognerebbe renderle merito.
Vogliamo aggiungere il Fatto di sangue tra due uomini – adesso proviamo a scriverlo tutto – per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici (1978) con un triangolo tra un avvocato antifascista (Marcello Mastroianni), un boss fascista (Turi Ferro) e il gangster Nick (Giancarlo Giannini) che si scannano attorno a Concetta, detta Titina (Sophia Loren)? E ancora Scherzo del destino in un agguato dietro l’angolo come un brigante di strada in cui nel tritacarne finiscono i servizi segreti, il terrorismo, i ministri, le mogli, Gianni Agnelli, gli amanti e pure i Carabinieri?
Lina ama sovraccaricare le maschere per smascherarle ed estrarne gli estri primordiali, gode a far deflagrare i suoi personaggi e le sue storie con l’istinto killer del bambino che vuole il giocattolo ma solo per romperlo e esibirne felice i pezzi. Una vitalista eslege e agonistica che forse in questo modo ha voluto esorcizzare l’ombra oscura che circonda la vita.
D’altronde, cominciò così il suo cammino, dopo aver attraversato il teatro dei burattini, poi quello di Giorgio De Lullo e di Garinei & Giovannini, ed essere approdata attraverso l’amica Flora Carabella sui set felliniani, aiuto-regista in La dolce vita e 8½, (“Fellini? “Immenso, divertentissimo, una finestra su un modo sconosciuto”).
Cominciò con la regia di una Canzonissima e quella della riduzione per la televisione de Il Giornalino di Giamburrasca (1964), con l’elettrica e indisciplinata Rita Pavone a interpretare Giannino Stoppani, un botto di ascolti e una sigla memorabile con la musica di Nino Rota e i testi di Lina. Rita che in quegli anni mieteva successi discografici e sempre con Wertmüller avrebbe girato due film esuberanti e giovanilistici, Rita la zanzara (1966), citazione di un’irriverente rivista studentesca di un liceo milanese, e un anno dopo il sequel Non stuzzicate la zanzara. In entrambi la protagonista è una studentessa in combutta musical-amorosa con il prof. Paolo che segna il debutto con Lina di Giannini. Lei si firma G. Brown che sarà anche lo pseudonimo con cui dirige Il mio corpo per un poker (1968), un western all’italiana nella sua maniera fracassona e casinista con Elsa Martinelli. Sono anche gli anni in cui conosce lo scenografo-costumista Enrico Job che diventa l’inseparabile compagno e marito di una vita.
Intanto, con tutta la determinazione possibile, Wertmüller ha perseguito il passaggio a un cinema che fosse tutto suo, di Lina Wertmüller. Ed ecco finalmente I basilischi (1963) un simil-Vitelloni se non fosse ambientato nel paese del padre della regista con tre giovanotti immersi in una noia-apatia orizzontale che, rivisto postumo, è il punto zero da cui partono le traiettorie isteriche e espressioniste dei film a venire. Il primo, Questa volta parliamo di uomini (1965), quattro episodi tutti con Nino Manfredi che del maschio esprime tutti i vizi e gli stereotipi possibili e povere le donne che gli capitano a tiro. E cominciano le polemiche…