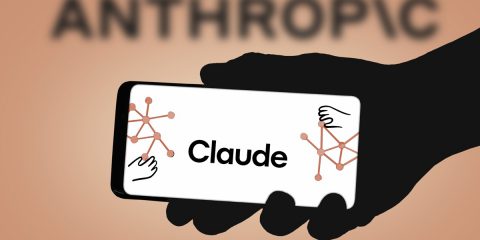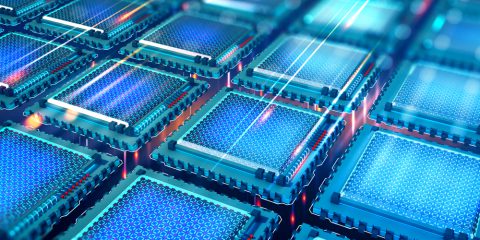Nei giorni scorsi, grazie ad un invito del Comune di Genova, ho potuto partecipare ad una sessione del progetto Urbact, un’iniziativa dell’Unione Europea che promuove la collaborazione fra le città per elaborare soluzioni e linguaggi d’integrazione dei social nel governo del territorio, sollecitato tenacemente da una vitalissima presenza dell’ANCI.
Il gruppo era composto dai rappresentanti di alcune grandi metropoli, come Genova e Palermo ma anche Parigi e l’ospitante Lisbona, e realtà medio-piccole fra cui la spagnola Murcia o la rumena Alba Giulia.
Interessante l’impegno, pressoché ormai uniforme in ogni progetto di governance urbana, per studiare forme di ottimizzazione delle risorse dei social nell’ambito dei processi amministrativi.
La smart city ormai è una categoria trasversale che congiunge culture e forme delle politiche del territorio in tutto il mondo. Lo spaccato del personale presente a Lisbona – dalle figure politiche come gli assessori dei comuni, alle figure dirigenziali, come i responsabili dei comparti comunicazione e innovazione – presentava forti caratteri di identità comune.
Diciamo che si sta ripetendo con le forme di digitalizzazione delle città, lo stesso fenomeno che negli anni ’70-‘80 caratterizzò i processi di pianificazione urbanistica del territorio con i processi di coinvolgimento nell’elaborazione dei piani regolatori territoriali e la spinta al decentramento metropolitano.
Come allora, anche oggi si sta configurando un ceto tecnico professionale, che per linguaggio e competenze converge su uno stesso standard: generalmente quarantenni, con matrice professionale giornalistica, e attitudine alla promozione culturale, che acquisiscono competenze informatiche, e comunque sistemistiche, e procedono con sensibilità sociologiche.
E’ un ceto amministrativo nuovo, che usa il linguaggio della comunicazione per produrre soluzioni e servizi. Un ceto che soffre l’ancora lenta maturazione dei livelli politici.
Ovunque infatti si coglieva una certa insoddisfazione, se non proprio frustrazione, per i propri vertici politici, sindaci ed assessori, che tendono sia per utilitarismo – cercare il consenso immediato – sia per miopia culturale, ad usare le tecnicalità della smart city più per immagine che per una reale volontà di trasformazione degli apparati.
In realtà il vero limite è rintracciabile proprio in questa relazione fra il livello politico e quello dell’apparato. In entrambi i casi, vivendo ognuno per la sua parte l’esperienza innovativa come una trasgressione, una pratica momentanea borderline, in cui ogni iniziativa viene pesata per l’effetto immediato e soprattutto per la sua compatibilità con i modelli organizzativi pregressi, si cerca di avere una copertura nelle decisioni e un sostegno nella gestione rifugiandosi nel ventre dei grandi cetacei della rete, ossia i giganti che monopolizzano i servizi online, come Facebook, Google, Amazon.
Organizzare modelli di partecipazione social diventa sinonimo di stare su Facebook o su Twitter.
Per cui si assiste ad un singolare meccanismo, dove l’Unione Europea investe risorse ingenti per finanziare queste pratiche relazionali fra i comuni, e i comuni trasferiscono, quando riescono a completare i progetti, risorse e soprattutto dati, ai giganti digitali, che alla fine del ciclo sono gli unici beneficiari della strategia innovativa.
Certo che oggi per un comune, tanto più se di medio-piccole dimensioni, appoggiarsi alla realtà di Facebook o di Twitter garantisce un’operatività immediata. Ma la logica di queste iniziative consortili, promosse dall’Unione Europea con ingenti risorse comunitarie, dovrebbe essere proprio quella di dotare le amministrazioni locali, di una massa critica e di un asset di saperi tale da permettergli di poter sperimentare forme innovative e non semplicemente la riproduzione di quanto fanno individualmente già i propri cittadini ammassandosi sui grandi social.
Tanto più in una fase come l’attuale, in cui gli equilibri sono alquanto precari. Siamo infatti nel pieno della transizione al mobile, e sarebbe forse utile un approfondimento su questo processo che muta radicalmente tutte le forme e i modelli elaborati per il computer.
Il mondo, ci spiega l’ultimo rilevamento globale del Boston Group, si divide oggi fra chi è prevalentemente mobile e chi è solo mobile. Fra 3 anni questa distinzioni cadrà. E’ una grande opportunità per chi, come le amministrazioni territoriali, fa della mobilità una categoria della propria attività di governo.
Non sarebbe forse il caso di introdurre in questi progetti di Smart City un vincolo a pensare le attività direttamente su mobile per rendere i comuni più adeguati e attrezzati alle svolte di questa fase?
E non sarebbe il caso, piuttosto che continuare a finanziare ginnastiche digitali datate, di spingere i comuni a ragionare sui nuovi standard di relazioni basate sull’intelligenza artificiale, che ormai sarà quanto prima pratica corrente su tutti i grandi social?
Un comune non è quasi sempre anche un’università?
Non è spesso anche sede di centri di ricerca specializzati?
Non è luogo di transito di saperi e competenze?
Perché non lavorare sulle capacità di integrare e assemblare queste risorse del proprio territorio, più che nell’addestramento sui vecchi social?
Un comune oggi deve essere un impresario di innovazione più che un interprete.
Per questo, mi pare essenziale abbandonare l’insopportabile atteggiamento predicatorio per cui innovazione significa accesso tout court alla rete così come è. Questo è un atteggiamento che poteva essere giustificato 10 anni fa, quando nella fase iniziale, era essenziale accumulare esperienze e dimestichezze con i nuovi mondi.
Oggi, con il cambiamento di pelle della rete, che da motore di liberazione è diventata mercato di anime dominato da pochi grandi monopolisti, è essenziale, tanto più per un ente pubblico, costruire modelli digitali in literacy, ossia con un approccio autonomo, consapevoli e critici.
Il valore aggiunto da riversare sulla propria cittadinanza non è indotto dal trasferire i propri dati a Facebook, quanto a dotare ogni cittadini di strumenti e culture per renderlo competitivo e cooperante con il territorio.
Per questo il tema da affrontare è il seguente: ma un comune che è di per sé una community relazionale perché deve appaltare i propri linguaggi e soprattutto i propri dati ad un altro sistema relazionale?
In sostanza, oggi diventa indispensabile che i centri di pianificazione delle forme di relazione e di partecipazione digitale siano centri di pensieri strategici sulla rete più che di semplici abilità operative.
Su questo dovrebbero concentrarsi i fondi dell’Europa: finanziare le strategie autonome dei comuni e non le pratiche subalterne degli informatici. Altrimenti il rischio è quello di ripetere con i giganti digitali quanto accadde in Europa alla fine degli anni ’60, al sorgere delle nuove pratiche informatiche in cui, come denunciò uno straordinario saggio “La sfida americana” di Servant –Shreiber “noi europei paghiamo gli americani perché ci comprino”.
Ovviamente del tutto inascoltato da quella generazione di politici che oggi rimpiangiamo ingiustificatamente.