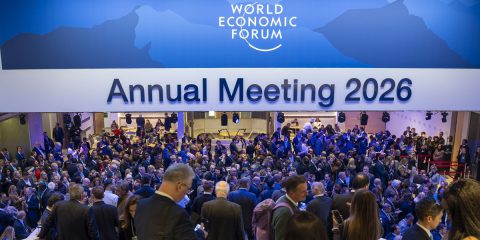Italia

Cyberdissidenti e cybercensori all’attenzione della Commissione per i Diritti umani del Parlamento. Nuove tecnologie e nuova censura a confronto, i punti cardini dell’audizione voluta da Heidi Hautala per mettere un freno alla ‘cyberguerra‘ in corso in tutto il mondo ed evidenziata in uno studio commissionato dai deputati, che mostra che non solo l’Unione Europea, ma anche le grandi imprese della rete, possono giocare un ruolo fondamentale in questa ‘battaglia’.
Ad una libertà di espressione sempre più vasta grazie alla rete, in alcuni paesi del mondo corrisponde, dunque, la ‘messa a punto’ di strumenti sempre più sofisticati per la censura digitale da parte di quelli che sono stati definiti ‘i nemici dei diritti umani’.
Allo stato attuale, è emerso nel corso dell’incontro, sono 60 i Paesi che praticano la censura online, e tra questi primeggia la Cina che oltre ad essere il più grande mercato digitale del mondo, rappresenta anche il più grande censore. Uno dei casi portati ad esempio dalla rappresentante dell’Ong ‘Reporter senza frontiere’ Lucie Morillon, è quello di Pechino che ha bloccato l’accesso a oltre 18.000 siti internet e imprigionato 72 dei 120 cyberattivisti presenti nel pianeta. Nella lista nera dei cybercensori figurano anche Arabia Saudita, Egitto, Birmania, Iran, Corea del Nord, Cuba, Siria, Tunisia e Vietnam.
Secondo Andrew Puddephat, che durante l’audizione ha presentato i risultati dello studio effettuato su Tecnologie della comunicazione e diritti umani, “le imprese di telecomunicazioni e media digitali sono ‘alleati potenziali importanti per i diritti umani’. Tuttavia – ha aggiunto – per le imprese la situazione non è facile”. “I governi chiedono strumenti di controllo e censura – ha continuato la Morillon – e ci sono compagnie che obbediscono come Yahoo e Microsoft, e altre più coraggiose, come Google”.
Molte, in effetti, le società occidentali che si piegano ai dettami dei governi censori, come Nokia Siemens Networks, finita nel mirino delle associazioni umanitarie per aver fornito all’Iran una tecnologia che permette di intercettare, monitorare e controllare le comunicazioni.
E mentre da una parte c’è NSN criticata da una risoluzione del Parlamento per l’accordo con Tehran che permetteva di intercettare praticamente qualunque utente di un cellulare di sua costruzione, dall’altra c’è Google, che da marzo di quest’anno ha deciso di smettere di censurare le ricerche in Cina inducendo gli utenti a scegliere google.hk (Hong Kong) piuttosto che google.cn.
La Cina pertanto, come denunciato l’attivista del Consorzio Global Internet Freedom, Shiyu Zhou “rappresenta il migliore esempio di cyberpolizia, filtraggio e ostruzione”. “Il Muro di Berlino del XXI secolo è usato per indottrinare, intimidire e perseguitare – ha detto – ma per ogni dollaro speso su tecnologie anti-censura, i governi devono spenderne migliaia per bloccarci”.
Hosuk Lee Makiyame, direttore dell’European Centre for International Political Economy, ha spiegato che la vera ragione della censura cinese è di natura commerciale e protezionista. Il governo blocca arbitrariamente solo i siti stranieri, mentre a quelli cinesi non succede niente. Sull’Iran, invece, Makiyame ritiene che “gli stessi mezzi tecnologici possano essere usati dai dissidenti per twittare e dal regime per reprimere”.
Due facce della stessa medaglia, dunque, e una guerra che va necessariamente combattuta dall’Unione Europea. Secondo Puddephat infatti, è l’UE che può e deve intervenire “stabilendo una normativa che faccia da esempio nel mondo, ma anche mettendo pressione sui paesi della censura nei forum internazionali, e lavorando con le imprese per far avanzare i diritti umani nell’ecosistema digitale. Si possono formare esperti di diritti umani online, e sostenere i progetti e le ONG che creano strumenti per la libertà di espressione su internet“.
Sulla stessa lunghezza d’onda, Heidi Hautala che promesso l’avvio di un lavoro serio e continuo per identificare le possibili aree di azione e Lucie Morillon che chiede ai politici europei di “incoraggiare le imprese delle ICT a creare un codice di condotta volontario, ma anche insistere per il rilascio dei cyberdissidenti”.