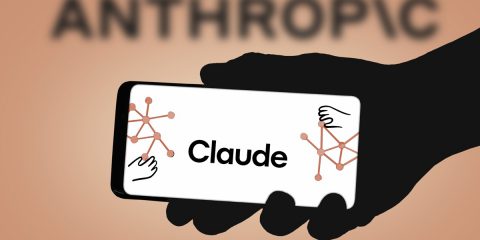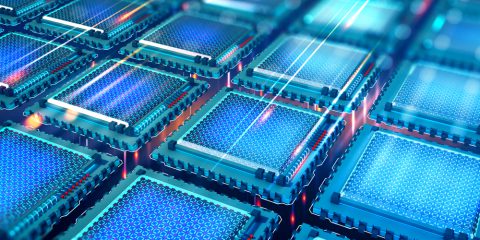La Corte Suprema degli Stati Uniti sta discutendo il caso Gonzalez contro Google. Google sappiamo bene cosa è, Gonzalez è la famiglia di una studentessa universitaria americana, Nohemi, uccisa quando aveva 23 anni durante l’attacco terroristico di Parigi del novembre 2015. I familiari della studentessa hanno fatto causa a Google, perché ritengono che l’algoritmo di YouTube che seleziona e propone i video agli utenti abbia promosso la diffusione di contenuti dell’ISIS, contribuendo così a causare la morte della loro figlia. Il caso potrebbe rappresentare una svolta se definirà nuovi profili di responsabilità dei giganti del web, come Google, e dei loro algoritmi nel promuovere la diffusione di contenuti pericolosi per i cittadini. E soprattutto se porterà a considerare le piattaforme digitali come dei veri e propri editori, cioè stabilirà la responsabilità editoriale delle piattaforme digitali per i contenuti che queste diffondono.
Il caso della famiglia Gonzalez contro Google
Finora i colossi del web non sono mai stati considerati veri e propri editori, ma soltanto diffusori di notizie. Questa condizione permette la diffusione di notizie senza averne una responsabilità simile a quella degli editori tradizionali. Questo viene contestato dai legali della famiglia Gonzalez, secondo i quali il sostegno ottenuto dall’ISIS è venuto proprio dal funzionamento degli algoritmi dalla piattaforma di Google che promuove la diffusione delle informazioni per aumentare la loro visibilità senza curarsi della loro pericolosità. I giudici della Corte Suprema dovranno pronunciarsi sulla validità della Section 230 del Communications Decency Act del 1996 che stabilisce che le piattaforme digitali non sono penalmente responsabili, come autori o editori, per i contenuti realizzati da terzi.
Questa storia, che potrebbe cambiare la giurisprudenza degli USA, rappresenta uno di tantissimi casi in cui invece gli algoritmi delle piattaforme agiscono come dei veri e propri editori tramite le loro sofisticate modalità di elaborazione dei contenuti informativi che vengono proposti agli utenti. Quei giudici, anche se credono che Google non sia un editore in sé, farebbero bene a considerare che i suoi algoritmi in realtà lo sono per come gestiscono i contenuti, per come li mettono in evidenza e per come ne dirigono la diffusione, facendolo forse meglio di editore umano.
L’epoca digitale in cui viviamo ha generato capovolgimenti di ruoli storici, tra questi c’è quello che vuole affidare alle macchine la scrittura dei testi (ChatGPT docet) e agli umani soltanto la lettura. C’è anche un’inversione informativa per la quale non sono i lettori a cercare le notizie ma sono queste ultime a cercarsi chi le dovrà leggere. Questo avviene non sulla base dei contenuti delle notizie, quindi non sull’interesse verso il ‘conosciuto’ che contengono, ma seguendo gli algoritmi dei motori di ricerca e delle piattaforme dei social media che decidono il posizionamento automatico delle pagine di news di cui sono pieni il web e le app social. Lettori, autori, giornali, siamo tutti obiettivi dell’algoritmo di ricerca di Google, dei News Feed delle piattaforme social e della search engine optimization (la cosiddetta SEO) usata per posizionare in evidenza i contenuti online. Questi algoritmi compongono continuamente le notizie, le mettono in ordine, le propongono sulla base di logiche commerciali e non tanto informative.
Chi cerca una notizia si piega alla selezione algoritmica ed è spinto in un ‘cunicolo informativo’ che troppo spesso non è guidato dall’esattezza, dalla qualità, dal tasso di verità o dalla novità. I redattori umani, invece di concentrarsi sul contributo informativo, si devono attrezzare per inserire le giuste parole chiave nei titoli e nelle frasi dei loro articoli. Come se si volessero inchinare ai presunti desideri dei lettori, mentre nei fatti si inchinano ai programmatori di Google e dei social media, in una lotta tra il gatto digitale e il topo informativo, cercano di valorizzare i loro contenuti lavorando sulla migliore esposizione online possibile. L’effetto globale è che la notizia non insegue l’originalità ma rincorre l’algoritmo e tutto questo inedito processo (dis)informativo genera una regressione che riporta indietro un antico e nobile mestiere, facendolo regredire dal valore del significato e della novità al semplice matching lessicale. Il quadro futuro prevede che saranno gli algoritmi della intelligenza artificiale generativa a inserire le parole giuste che altri algoritmi cercheranno per servire ai lettori quello che si presume debba interessare loro.
A tutto questo bisogna aggiungere il tema fondamentale della de-medializzazione dell’informazione che l’online ha introdotto. Oggi tutti siamo potenziali fornitori di notizie, tutti possono contribuire a scrivere testi che diventano brevi articoli o post online. Questo viene fatto spesso senza verificare le fonti, con approssimazione e a volte amplificando fake news. Tutto questo ha cambiato l’universo dell’informazione. A questo cambiamento stanno contribuendo anche gli algoritmi di raccomandazione che compongono e ordinano le notizie online che leggiamo o i video che vediamo. Sono i nuovi redattori, i nuovi impaginatori che si sottraggono alle loro responsabilità.
Di questo nuovo ma importante scenario, dovrebbero tenere conto i giudici della Corte Suprema USA che dovranno prendere una decisione nella causa tra la famiglia Gonzalez e Google. Un’eventuale decisione che tenga conto del nuovo ruolo editoriale degli algoritmi servirebbe per considerare con attenzione la profondità dei cambiamenti nell’informazione introdotti dal digitale. Per riconoscere la novità delle trasformazioni e per aiutare i cittadini a identificare il potere delle piattaforme e, quando possibile, provare a sottrarsi ad esso e seguire fonti di informazione affidabili.