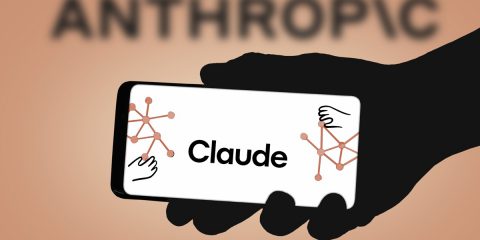Negli ultimi mesi, i media e l’immaginario collettivo sono stati invasi da una pletora di parole nuove, accomunate dall’essere sorte all’interno dell’ecosistema blockchain, il cui significato oscilla tra l’esoterico e il futuribile: metaverso, smart contract, NFT, DAO, DEFI, cryptoarte, cryptovalute, stablecoins, token, web 3.0. L’ultimo termine è quello che ha iniziato a materializzarsi per ultimo a livello di dibattito pubblico, ma che merita sicuramente attenzione in quanto caratterizzato da una maggiore capacità d’impatto rispetto agli altri: con “web 3.0” si intende la nuova fase del web, quell’entità tanto magmatica quanto immateriale, nata dalla schiuma dell’ultimo afflato tecnologico del ventesimo secolo, che permetterebbe all’individuo di riappropriarsi del controllo sui propri dati. Si potrebbe dire, in altri termini, e seguendo la logica di fondo che ha portato alla coniazione della parola web 3.0, che questo nuovo paradigma permetterebbe alle persone di interagire con il web non più come “oggetti” su cui le big tech fanno utili (l’individuo ormai ridotto a prodotto, da vendere a peso, in base alla quantità di dati personali che da lui o lei si possono estrarre) ma come “soggetti”, produttori e utenti al tempo stesso.
Il termine web 3.0, nell’accezione qui utilizzata (si è parlato anche di web 3.0, in un altro contesto, per designare il web semantico) è stato proposto per la prima volta nel 2014 da Gavin Wood, uno dei creatori di Ethereum, e successivamente della blockchain Polkadot, per designare il passaggio a una nuova fase del web segnata dalla decentralizzazione, dalla disintermediazione e, quindi e fondamentalmente, dal controllo delle persone sui propri dati. Secondo questa tesi, il paradigma del web 3.0 andrebbe collocato all’interno di una evoluzione di modelli tecnologici e di business che hanno interessato l’architettura di internet e del world wide web. La prima fase è stata la creazione di internet, un protocollo di trasmissione dati, nato prima in ambito militare e, poi, diffusosi nel mondo accademico. Si è, poi, sviluppato il web 1.0, cioè un gigantesco sistema d’informazione, caratterizzato dalla creazione di pagine web statiche consultabili dagli utenti a richiesta. La fase successiva, che ancora caratterizza in misura preponderante il mondo attuale, è quella del web 2.0, vale a dire un vasto e pervasivo ecosistema di applicazioni che permettono alle persone di interagire in molteplici ambiti, spingendole a una continua “engagement”, cioè attività on-line, poiché tali applicazioni generano fatturato attraverso le azioni che gli individui eseguono e/o estraendo dati dai loro comportamenti: il mondo dei social network come Facebook o Linked in, ma anche dei colossi della sharing economy come Airbnb o Uber.
Secondo Wood, il web 3.0 sarebbe la risposta (e la soluzione) al web 2.0, in quanto si tratterebbe di un sistema sostanzialmente decentralizzato capace di collegare in modo diretto le informazioni e le applicazioni costruite sul web agli individui-utenti, rimuovendo, quindi, i soggetti che guadagnano con il controllo dei dati (come Facebook) o con l’intermediazione (come Airbnb).
In termini icastici, è ricorrente l’affermazione, tra i teorici del web 3.0, secondo cui il web 1 era caratterizzato dal “read” (cioè il “search”), il web 2.0 dal “read and write” (cioè dal “social”) e il web 3.0 dal “read, write and own” (cioè dal “user ownership of digital assets” da intendere nel senso di proprietà dei dati personali).
Gavin Wood ha anche creato la Web 3.0 foundation, con sede a Zug, Svizzera, che, nel sito, dichiara: “our passion is delivering Web 3.0, a decentralized and fair internet where users control their own data, identity and destiny”.
E’ interessante riportare uno scambio di Tweet tra i titani della Silicon Valley, che ha avuto una certa eco nei blog e i magazine (in lingua inglese) che trattano della nuova cryptoeconomy, il quale aiuta a porre in contesto (e a comprendere meglio) il web 3.0. Elon Musk, CEO di Tesla e uomo più ricco del Pianeta, il 20 dicembre 2021, ha twittato che “has anyone seen web3? I can’t find it”. Jack Dorsey, uno dei fondatori di Twitter e, poi, di Block, società di fintech fortemente orientata alle cryptovalute, lo stesso giorno gli ha risposto che “it’s somewhere between a and z” e, poi, il giorno dopo, ha twittato: “you don’t own “web3”. The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label. Know what you’re getting into…”. Il primo tweet di Dorsey è un riferimento ad Andreesen Horowitz, una delle maggiori società di venture capital della Silicon Valley, con più di 20 miliardi di dollari di asset under management, che ha, a oggi, investito più di 3 miliardi di dollari nella cryptoeconomy (investendo in circa 12 società, incluse OpenSea e Dapper Labs); il secondo tweet, invece, è un attacco, tanto generico quanto sufficiente chiaro, alle società di venture capital. Il posizionamento di Andreesen Horowitz a difesa della cryptoeconomy è, altresì, ben rappresentato dalle dichiarazioni pubbliche espresse da Chris Dixon, uno dei partner di Andreesen Horowitz, il quale, in particolare, in una serie di tweet, scrive che “web 1 (roughly 1990-2005) was about open protocols that were decentralized and community-governed. Most of the value accrued to the edges of the network — users and builders” e, poi, che “web 2 (roughly 2005-2020) was about siloed, centralized services run by corporations. Most of the value accrued to a handful of companies like Google, Apple, Amazon, and Facebook” e che “we are now at the beginning of the Web 3 era, which combines the decentralized, community-governed ethos of Web 1 with the advanced, modern functionality of Web 2” e, infine, che “web 3 is the internet owned by the builders and users, orchestrated with tokens”.
In un articolo del blog di Andreesen Horowitz, Dixon fornisce, altresì, probabilmente la spiegazione migliore, e più trasparente, di cosa effettivamente sia il web 3.0: “Centralized platforms follow a predictable life cycle. At first, they do everything they can to recruit users and third-party complements like creators, developers, and businesses” e “when they hit the top of the S-curve, their relationships with network participants change from positive-sum to zero-sum. To continue growing requires extracting data from users and competing with (former) partners” dopodiché, secondo Dixon, “now let’s talk about web3. In web3, ownership and control is decentralized. Users and builders can own pieces of internet services by owning tokens, both non-fungible (NFTs) and fungible”.
Al di là della lite da cortile tra ricchi della Silicon Valley (i quali chiaramente hanno precise ragioni di business per disquisire pubblicamente su Twitter), il summenzionato scambio di strali, in realtà, riporta allo stesso momento fondativo della blockchain: uno degli scopi principali, se non il principale (l’altro era, ovviamente, quello di guadagnare direttamente dal prevedibile aumento di valore del bitcoin nel tempo), del gruppo di programmatori, la cui identità non è nota (ma solo lo pseudonimo, “Satoshi Nakamoto”, dietro cui si celano), che ha sviluppato il sistema del bitcoin era molto probabilmente quello di innestare un processo che potesse portare, presto o tardi, alla fine del controllo delle big tech (Facebook, Google, Amazon, Apple) sui dati delle persone. Sarebbe ingenuo, tuttavia, e al di là dei proclami, pensare che il fine ultimo degli sviluppatori della blockchain e dei suoi sviluppi, come il web 3.0, sia stato quello di far riappropriare gli individui della propria “esistenza digitale”: sembra più corretto poter leggere nello sviluppo di questi nuovi modelli di tecnologia il tentativo di scardinare il potere delle big tech per favorire l’ecosistema di start up e imprese della Silicon Valley che, nel bene o nel male, aspirano a crescere e a diventare unicorni o quotarsi nei mercati finanziari.
Come è noto, infatti, le big tech, ormai da anni, stanno paralizzando la concorrenza nel mercato della Silicon Valley, effettuando acquisizioni killer per comprare ed eliminare dal mercato potenziali concorrenti prima che possano crescere. In tal senso, una società di venture capital come Andreesen Horowitz ha ovviamente interesse a spingere un modello tecnologico e di business che agevoli la nascita di imprese – start up, PMI o unicorni – poiché guadagna dalla crescita degli investimenti in equity nelle start up, mentre un sistema schiacciato sotto il peso dell’oligopolio delle big tech lascia poco spazio ad altre società di crescere e generare valore. Si potrebbe dire che, se i regolatori (l’antitrust americana o quelle europee; i Garanti europei della privacy, etc.) non sono ancora effettivamente riusciti a porre un freno alle big tech, è il mercato stesso ad aver (forse) sviluppato un antidoto contro le distorsioni dei grandi oligopolisti del mercato tecnologico. Sebbene questa affermazione possa essere considerata in larga parte speculativa, rimane, tuttavia, sicuramente vero che l’ecosistema che si sta sviluppando sul terreno, magari ancora incolto, della blockchain e della tokeneconomy offre diverse opportunità di business e di crescita alle PMI europee che i campi coltivati, ben recintati e protetti, delle big tech sicuramente non offrono.