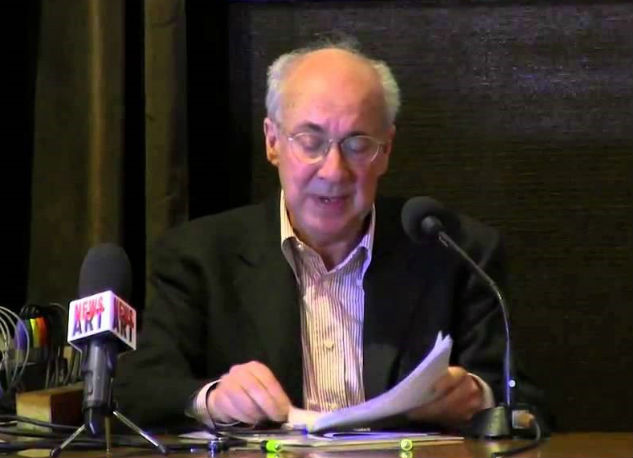
Marco Mele afferma che “Il disastro delle telecomunicazioni italiane non viene da lontano“, descrivendo “La triste parabola dalla Stet a Telecom Italia”. “Lo Stato imprenditore viene da lontano. Il disastro delle telecomunicazioni italiane non così da lontano ma discende da quello. Vi è un punto in comune: essere stati entrambi condizionati da pochi interessi privati a scapito della comunità nazionale. Con la costituzione dell’Iri, nel 1933, le tre grandi banche nazionali, Banca Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma, cedevano all’istituto le loro partecipazioni industriali. Lo Stato diventava proprietario del 20 per cento dell’intero capitale azionario nazionale […]. L’Iri emetteva prestiti obbligazionari garantiti dallo Stato e sottoscriveva il capitale delle società finanziarie, che a loro volta controllavano quelle operative. Così nel 1934, nasceva la Stet. Nel dopoguerra l’Iri mantenne la struttura che aveva sotto il fascismo. […] a partire dagli anni Ottanta, comincia il “ripensamento” sulla gestione delle aziende pubbliche: Romano Prodi dopo i salvataggi statali [avvia una] la politica di cessioni e liquidazioni. Un decennio dopo L’Europa. ha un ruolo decisivo per avviare la stagione delle privatizzazioni, con l’accordo fra il Commissario europeo alla concorrenza Karel Van Miert e Beniamino Andreatta del 1993. Il Tesoro sceglie di non privatizzare l’Iri spa, ma le aziende operative”. L’articolo prosegue analizzando gli anni “Dalla nascita di Telecom Italia nel luglio 1994 dalla fusione di SIP con Iritel, Telespazio, Italcable e SIRM, tutte società operative nelle telecomunicazioni”, (fusione che costituisce per Mele “l’anticamera della privatizzazione”), alla fusione della stessa Telecom Italia con la Stet nel 1997 “con la nascita della cosiddetta Supersip, che concentra sotto il marchio Telecom Italia tutte le attività operative nella società da privatizzare”, e l’avvio nell’ottobre dello stesso anno della privatizzazione “con la cessione del 35,26 per cento del capitale di Telecom Italia e un introito di 26 mila miliardi di lire. Un successo per lo Stato? Le operazioni industriali e finanziarie vanno sempre giudicate nel tempo. La scelta del “nocciolo duro” nasce dall’illusione che la società potesse essere gestita e potesse crescere grazie a un gruppo di azionisti privati in minoranza nel capitale, ma con un forte potere di “scambio” con la politica (Ifil in testa) […] Nessuno può avere più del 3 per cento del capitale. Nessuno neanche si avvicina a tale percentuale. L’IMI, maggior investitore, rileva lo 0,8 per cento”. Ma le aspettative si rivelano subito illusione: un mese dopo “Le dimissioni di Guido Rossi nel novembre del 1997 rivelano molto presto le profonde crepe della Telecom “privata”. Di qui la caduta del gigante descritta in vari paragrafi: “Gli avvicendamenti alla guida dell’ex incumbent italiano e l’OPA di Olivetti del febbraio 1999”, “Il giallo della vendita di Seat-Pagine Gialle e la crescita dell’indebitamento”, “Il tentativo di Telecom Italia di sfidare il duopolio Rai-Mediaset e il “soccorso” bresciano”, il perfezionamento nel 2003 della fusione Olivetti-Telecom Italia e la successiva cessione quattro anni dopo nell’aprile 2007 “a una cordata italo-spagnola composta da Mediobanca, Generali, Banca Intesa, Benetton e dalla spagnola Telefonica”. Dopo aver descritto questo lungo processo che porta al ridimensionamento di una società ormai “priva di proiezioni internazionali di rilievo”, Mele si sofferma in conclusione su alcuni su “I lati oscuri della vicenda e il tracollo tecnologico del sistema Italia [che relega l’ex incumbent, nel frattempo ridenominato TIM] ai margini delle telecomunicazioni”.
****
Lo Stato imprenditore viene da lontano. Il disastro delle telecomunicazioni italiane non così da lontano ma discende da quello. Vi è un punto in comune: essere stati entrambi condizionati da pochi interessi privati a scapito della comunità nazionale. Con la costituzione dell’Iri, nel 1933, le tre grandi banche nazionali, Banca Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma, cedevano all’istituto le loro partecipazioni industriali. Lo Stato diventava proprietario del 20 per cento dell’intero capitale azionario nazionale, controllando aziende come Ansaldo, Terni, SIP, SME e Alfa Romeo, l’industria degli armamenti, i servizi di telecomunicazione, la produzione di energia elettrica, tra l’80 e il 90 per cento delle costruzioni navali e buona parte della siderurgia.
L’Iri emetteva prestiti obbligazionari garantiti dallo Stato e sottoscriveva il capitale delle società finanziarie, che a loro volta controllavano quelle operative.
Così nel 1934, nasceva la Stet. Nel dopoguerra l’Iri mantenne la struttura che aveva sotto il fascismo. Crescevano nel tempo la cooperazione e la suddivisione dei compiti con i privati, anche nello sviluppo della rete telefonica. Crescevano i salvataggi di aziende private in crisi, come del resto accaduto con le grandi banche sotto il fascismo. L’Iri “salva” Motta come i Cantieri Navali Piaggio e acquisisce gli alimentari da Montedison, nome fatale nella storia del secondo Novecento nazionale. Aumentano i dipendenti (i 218.529 nel 1950 diventano 556.659 nel 1980) e aumenta, dagli anni Settanta, l’indebitamento con le banche.
Il ripensamento di Romano Prodi dopo i salvataggi statali la politica di cessioni e liquidazioni
Nel tempo, a partire dagli anni Ottanta, comincia il “ripensamento” sulla gestione delle aziende pubbliche. Romano Prodi diventa presidente dell’Iri nel 1982. La sua presidenza porta alla cessione di 29 aziende, tra cui l’Alfa Romeo, la liquidazione di Finsider, Italsider e Italstat, lo scambio di aziende tra Stet e Finmeccanica e la tentata vendita della SME a Carlo De Benedetti, bloccata da una cordata di imprese che comprendeva Fininvest oltre a Ferrero e Barilla.
Una delle vicende che dimostra, a metà degli anni Ottanta, l’intreccio ormai indissolubile tra politica e affari, tra finanza privata e classe dirigente. Mani pulite nasce da qui. L’Europa. ha un ruolo decisivo per avviare la stagione delle privatizzazioni, con l’accordo fra il Commissario europeo alla concorrenza Karel Van Miert e Beniamino Andreatta del 1993. Il Tesoro sceglie di non privatizzare l’Iri spa, ma le aziende operative.
Un passo indietro, collegandosi ai fili della rete telefonica nazionale.
Nel 1933 l’Iri aveva fondato la Stet. In quell’anno la SIP (Società idroelettrica piemontese) fu coinvolta nel crollo della Banca Commerciale Italiana e venne salvata dall’Iri tramite la Stet. Trenta anni dopo, nel 1964, tutte le società del settore telefonico vennero incorporate in SIP. La capogruppo Stet, negli anni Ottanta arriva a fatturare fino a 14.400 miliardi di lire, con 136 mila dipendenti.
Un altro passo indietro: il sistema telefonico italiano era stato organizzato dal fascismo in cinque zone gestite da cinque operatori differenti, due dei quali, dal dopoguerra, controllati da privati, sino al 1957, poi riuniti per decreto nel 1964 nella SIP, che era stata premiata a livello finanziario dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica di due anni prima e dai relativi indennizzi. In quello stesso anno Stet controlla anche Telespazio, Radiostampa e Italcable, azienda di enorme importanza strategica per i collegamenti via cavo con l’estero.
Dalla nascita di Telecom Italia nel 1994 alla fusione con la Stet nel 1997 e l’avvio della privatizzazione
Telecom Italia nasce nel luglio 1994, dalla fusione di SIP con Iritel, Telespazio, Italcable e SIRM, tutte società operative nelle telecomunicazioni. E’ l’anticamera della privatizzazione.
Con il governo guidato da Romano Prodi e la presidenza di Guido Rossi, nel 1997 si crea la cosiddetta Supersip, concentrando tutte le attività operative nella società da privatizzare. Stet e Telecom Italia sono state fuse e prendono il nome della seconda. Seat Pagine Gialle viene scissa da Telecom Italia e nel 1996 ceduta a una cordata, Ottobi, in cui il gruppo De Agostini era il maggior azionista.
Il 20 ottobre 1997 parte l’operazione con la cessione del 35,26 per cento del capitale di Telecom Italia e un introito di 26 mila miliardi di lire. Un successo per lo Stato? Le operazioni industriali e finanziarie vanno sempre giudicate nel tempo. La scelta del “nocciolo duro” nasce dall’illusione che la società potesse essere gestita e potesse crescere grazie a un gruppo di azionisti privati in minoranza nel capitale, ma con un forte potere di “scambio” con la politica (Ifil in testa). Un altro “antipasto” di una privatizzazione poi rivelatasi catastrofica per il sistema Italia: nel 1995 partecipa alla nascita di Telecom Italia anche Asstel, azienda di stato che gestiva il traffico telesettivo. L’azienda di stato ha un ricco patrimonio immobiliare (Roma Fontana di Trevi, Milano via Cordusio) che, secondo molte interrogazioni parlamentari, viene volutamente sottostimato a vantaggio dei futuri privatizzatori. Nel 1997 parte la madre di tutte le privatizzazioni. Nessuno può avere più del 3 per cento del capitale. Nessuno neanche si avvicina a tale percentuale. L’IMI, maggior investitore, rileva lo 0,8 per cento.
Il prezzo di collocamento in Borsa è di 10.908 lire ad azione (5,5 euro circa), che scende a 10.795 per i dipendenti Telecom. Oggi le azioni Telecom viaggiano sui 2 euro. Chi avesse tenuto le azioni Telecom fino ad oggi avrebbe perduto più o meno il 169 per cento di quanto investito (per i dipendenti era possibile utilizzare anche il TFR, grazie ad un accordo con i sindacati). L’operazione porta al Tesoro (direttore generale; Mario Draghi) un buon gruzzolo di miliardi di euro.
Gli avvicendamenti alla guida dell’ex incumbent italiano e l’OPA di Olivetti del febbraio 1999
Le dimissioni di Guido Rossi nel novembre del 1997 rivelano molto presto le profonde crepe della Telecom “privata”. Viene nominato presidente Gian Mario Rossignolo. Vito Gamberale e Francesco De Leo vengono nominati a direttore generale ma dopo cinque mesi Gamberale si dimette da Telecom Italia per dissidi con Rossignolo e dopo un altro mese e mezzo lascia anche Tim. L’azienda resta nove mesi senza amministratore delegato.
Nell’ottobre 98 Rossignolo lascia la presidenza, caratterizzata da risse interne e da risse tra gli azionisti oltre che da una serie di accordi mancati (AT&T e Cable & Wireless). Il titolo cala in Borsa. Comincia l’era di Franco Bernabè, che da sei anni guida l’Eni. Non durerà altrettanto a Telecom Italia. Viene nominato nel novembre 1998.
Il 20 febbraio 1999 Olivetti lancia l’Opa su Telecom Italia. Comincia la guerra (per il controllo) di Telecom. A perderci saranno lo stesso gruppo telefonico, i dipendenti e i risparmiatori. A favore dell’Opa di Roberto Colaninno lavorano da una parte Enrico Cuccia, dall’altra Massimo D’Alema. Infostrada e Omnitel vengono vendute da Olivetti al gruppo Mannesmann per finanziare l’operazione; continua la cessione all’estero del patrimonio tecnologico e trasmissivo nazionale, avviato con la cessione di Telettra dalla Fiat ai francesi di Alcatel. Su questo aspetto poco scrivono e dicono analisti e giornalisti, attratti piuttosto dal Risiko politico-finanziario della vicenda.
L’Opa non viene bloccata perché manca il si del 30 per cento degli azionisti in assemblea dei soci. Il 29 febbraio la Consob dà il via libera all’operazione. Olivetti è controllata da Bell, di stanza in Lussemburgo. Arriva al culmine l’era delle Matriosche o scatole cinesi che dir si voglia. Il 21 maggio 99 Olivetti annuncia di aver superato il 50 per centio di adesioni all’Opa, che è quindi riuscita, nonostante la resistenza e le controproposte di Bernabè. Quel 51 per cento equivale per il gruppo a un debito di 25,5 miliardi di euro. Olivetti con 1,3 miliardi di fatturato e 16 miliardi di debiti rileva Telecom che nel 1999 fattura 27,1 miliardi di euro e ha solo 8,1 miliardi di euro di debiti. Debiti che sono da saldare da parte di Telecom Italia.
Il giallo della vendita di Seat-Pagine Gialle e la crescita dell’indebitamento
Telecom Italia, per esempio, ”sostiene” l’acquisto di Seat-Pagine Gialle da parte della cordata Ottobi guidata da De Agostini, assicurando dieci anni di contratti pubblicitari oltre a una quota di acquisto. Telecom Italia paga 173 milioni sugli 853 totali la quota di una società già “pagata” con il contratto decennale dalla stessa Telecom Italia (che sarebbe il venditore). Nel 2001 i debiti dell’ex incumbent salgono a 21.9 miliardi di euro.
Non si è ancora toccato il fondo: durante la gestione di Marco Tronchetti Provera l’indebitamento netto del gruppo sale da quei 21,9 miliardi di euro del 2001 ai 37,3 miliardi del 2006. Nel frattempo, infatti, l’Opa lanciata da Telecom su TIM, già controllata al 56 per cento, eleva l’indebitamento, che arriva fino a 46.7 miliardi come dato intermedio del 2005.
Non basta. Nel 2000 Telecom Italia ricompra Seat a 20 miliardi di euro, per fonderla con Tin.it. Gran parte del costo di acquisizione viene recuperato con l’elargizione di un maxi dividendo agli azionisti. Il titolo vola in borsa a 12 euro, nel periodo della prima Bolla Internet. Colaninno ricompra Seat a debito, incassando sempre un super dividendo a copertura (qualche super consulente si diverte a chiamarlo leverage buy out, ma è solo uno strumento per spolpare l’azienda).
Nel 2003 arriva l’OPA di alcuni Fondi su Seat, che prendono il 62 per cento della società pagando realmente solo il 25 per cento della stessa. Il debito viene trasferito, anche in questo caso, dev’essere un vizio, sulla società. La Seat si ritrova con una montagna di debiti ma continua la prassi dei dividenti altissimi, per cui nel 2008 si licenziano 300 lavoratori e si chiudono alcune controllate all’estero. La vicenda Seat conosce diversi tracolli: il 31 agosto 2012, ad esempio, in un solo giorno il titolo perde il 67 per cento del valore. L’azione Seat arriva a valere circa 0,48 euro.
Il tentativo di Telecom Italia di sfidare il duopolio Rai-Mediaset e il “soccorso” bresciano
Torniamo a Telecom Italia, che in Borsa comincia a sua volta a perdere colpi, e così il titolo Olivetti. Colaninno vara il progetto di mutare Telemontecarlo in La 7 per sfidare il duopolio Rai-Mediaset. Sarà il suo canto del cigno. Suoi partner nella Bell sono alcune imprese bresciane, che fanno capo a Emilio Gnutti. Questo gruppo, caldamente “consigliato”, accetta l’offerta di Marco Tronchetti Provera per il 27,7 per cento delle azioni Olivetti nel luglio 2001. Per il gruppo bresciano vi è una plusvalenza di 1,8 miliardi di euro.
L’acquisto delle azioni Olivetti mediante Olimpia, società creata ad hoc, direttamente da Bell, permette a Tronchetti Provera di non lanciare un’Opa su Telecom Italia, molto più onerosa, a scapito – come al solito – dei piccoli azionisti.
Il progetto de La 7 è seppellito, la Edilnord di Fininvest passa a Pirelli Real Estate: chiamatele, se volete, “coincidenze”.
Arriva l’11 settembre 2001, il titolo crolla in Borsa come tutti quelli delle telecomunicazioni. I debiti di Telecom Italia arrivano a 51 miliardi di euro. Pirelli ha comprato azioni a 4 euro ciascuna, ora ne valgono due. La società Hopa di Gnutti è coinvolta nel disastro dei furbetti del quartierino, e vende la sua quota in Telecom Italia.
Si decide di vendere il 66 per cento di Olimpia, quota che permette il “governo” (parola grossa) di Telecom Italia.
I dipendenti, che erano 124 mila all’accorpamento delle società che hanno dato vita a Telecom Italia, sono scesi a 68 mila. In gran parte con prepensionamenti e mobilità. Costo per l’Inps; circa 500 milioni di euro per indennità di mobilità, anche questi da mettere nel conto dei danni apportati alla collettività nazionale. Diminuiscono i dipendenti ma crescono i subappalti, spesso affidati a tecnici e lavoratori della stessa Telecom Italia in mobilità.
Dal perfezionamento della fusione Olivetti-Telecom Italia alla cessione in mani straniere
Nel 2003 si è proceduto alla fusione Olivetti-Telecom Italia, caricando quest’ultima di tutti i debiti contratti da Olivetti per le varie scalate. L’indebitamento netto di Telecom passa dai 18,1 miliardi di euro del bilancio 2002 ai 33,3 miliardi del bilancio 2003. Partono dismissioni immobiliari, spesso effettuati a favore della Pirelli Real Estate e la cessione delle partecipazioni estere.
La strada della cessione di Telecom Italia in mani straniere, ultimo atto, finora, della vicenda è aperta: nell’aprile 2007 una cordata italo-spagnola composta da Mediobanca, Generali, Banca Intesa, Benetton e dalla spagnola Telefonica lancia un’offerta per la quota Pirelli in Olimpia. Telco è il veicolo per l’operazione ma i soci italiani escono da Telco, lasciando isolata Telefonica. Nell’ottobre 2015 il gruppo Vivendi, guidato da Vincent Bollorè, si muove sul mercato e nel 2016 arriva a detenere il 24,9 per cento, diventando primo azionista di Telecom Italia.
Nel marzo 2018 il fondo Elliot entra con il 3 per cento nel capitale e avvia azioni legali contro Vivendi. All’assemblea dei soci Elliot arriva con l’8,85 per cento del capitale e ha l’appoggio della Cassa Depositi e Prestiti (che investe i soldi dei risparmiatori postali) entrata con il 5 per cento. Il resto è cronaca, si pensi allo stop imposto da Agcom a Vivendi in Mediaset per il suo controllo su Telecom Italia. Divieto poi “asfaltato” dalla Corte di giustizia europea.
I lati oscuri della vicenda e il tracollo tecnologico del sistema Italia ai margini delle telecomunicazioni
Ma la storia di Telecom Italia, poi ribattezzata TIM, non è solo e tanto una storia politico-finanziaria, che ha prodotto una Telecom Italia ridimensionata, senza proiezioni internazionali di rilievo e con una quota di mercato in calo sul mercato nazionale, in mani straniere.
Ci sono due aspetti a mio avviso ancora più importanti della deriva politico-finanziaria finora accennata.
Il primo riguarda tutti noi, i nostri diritti, la nostra libertà. La magistratura scopre nel 2006 circa 6 mila dossier costruiti su intercettazioni effettuate o commissionate da soggetti operanti in Telecom Italia. Quello di Giuliano Tavaroli , ex capo della sicurezza in Pirelli e Telecom Italia, è il nome più uscito sui media insieme a quello di Marco Mancini, numero due del Sismi, ma dietro ci sono un gruppo di dirigenti e quadri della gestione di Marco Tronchetti Provera. La società Polis di Emanuele Cipriani fattura 20 milioni da Telecom Italia per attività di dossier e intercettazioni, Quando si dà ad un unico soggetto privato il potere su una società da cui passano le comunicazioni di milioni di italiani bisognerebbe predisporre strumenti di controllo e tutela dei cittadini utenti. Il caso arriva al pubblico con lo spionaggio contro Alessandra Mussolini prima delle elezioni regionali nel Lazio del 2005, ma è molto più vasto. Secondo i magistrati gli intercettati erano giudici, giornalisti, politici e perfino uomini di altri servizi. Vicenda costellata di misteri, come la morte nel 2006 di Adriano Bove, manager Telecom con incarichi nella sicurezza. Durante le udienze preliminari del processo Telecom-Sismi, nel 2009, il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, appone il Segreto di stato sui dossier illegali. Altro mistero è il Tiger Team, che doveva proteggere la Rete di Telecom Italia, ma che compiva veri e propri hackeraggi.
Il secondo riguarda il tramonto tecnologico del sistema Italia, cominciato con il ritardo nell’introduzione della televisione a colori e il conseguente fallimento delle aziende nazionali di elettronica di consumo. Una grave perdita per il sistema Italia fu la cessione della Telettra dalla Fiat ai francesi di Alcatel nel 1990, dopo il fallimento del progetto Telit di fusione fra la Telettra e l’Italtel. Non manca una legge di riforma Rai ad imporre l’assurdo cavo monocale, per salvare i monopoli esistenti. O investimenti sbagliati, come il satellite a diffusione diretta, troppo potente e costoso e con pochi canali irradiati. O come lo standard Dvb-h con il quale si voleva portare la televisione sui cellulari, e che prima di fallire servì a far siglare contratti molto, troppo onerosi per i contenuti delle reti televisive alle aziende telefoniche, Telecom Italia in testa.
Telecom Italia e le principali società telefoniche sono finite in mano di fondi e aziende non italiane con un ruolo importante tornato in mano al Tesoro. La vicenda della rete unica ha mostrato tutta la debolezza di Telecom Italia nell’attuale scenario delle telecomunicazioni. Lo Stato sta tornando ad essere imprenditore di fronte alla crisi portata dalla pandemia e dai fallimenti annunciati. Rilevare i residui di una privatizzazione fallimentare spesso non porta a grandi successi, quanto a successive cessioni di quote ad altri privati.














